Arte e Cultura
- Dettagli
- Categoria: Arte e cultura
Le religioni a Messina nella storia passata ed in quella attuale. Un racconto che comincia in un tempo lontano....
- Dettagli
- Categoria: Arte e cultura
 Il 28 dicembre 1908, era un lunedì, alle ore 5,21 del mattino, nella piena
oscurità e con gli abitanti immersi nel sonno, un terremoto
(tra i più potenti della storia italiana), che raggiunse i 7,1° grado
della scala Richter (11-12° nella scala Mercalli), seguito da un maremoto,
mise a soqquadro le coste calabro-sicule con numerose scosse
devastanti. La città di Messina, con il crollo di circa il 90% dei suoi
edifici, fu sostanzialmente rasa al suolo. Gravissimi i danni riportati
da Reggio Calabria e da molteplici altri centri abitati del
circondario. Sconvolte le vie di comunicazione stradali e ferroviarie nonché le linee telegrafiche e telefoniche. L’illuminazione stradale e cittadina venne di colpo a mancare a Messina, Reggio, Villa San Giovanni e Palmi, a causa dei guasti che si produssero nei cavi dell’energia elettrica e della rottura dei tubi del gas.
Il 28 dicembre 1908, era un lunedì, alle ore 5,21 del mattino, nella piena
oscurità e con gli abitanti immersi nel sonno, un terremoto
(tra i più potenti della storia italiana), che raggiunse i 7,1° grado
della scala Richter (11-12° nella scala Mercalli), seguito da un maremoto,
mise a soqquadro le coste calabro-sicule con numerose scosse
devastanti. La città di Messina, con il crollo di circa il 90% dei suoi
edifici, fu sostanzialmente rasa al suolo. Gravissimi i danni riportati
da Reggio Calabria e da molteplici altri centri abitati del
circondario. Sconvolte le vie di comunicazione stradali e ferroviarie nonché le linee telegrafiche e telefoniche. L’illuminazione stradale e cittadina venne di colpo a mancare a Messina, Reggio, Villa San Giovanni e Palmi, a causa dei guasti che si produssero nei cavi dell’energia elettrica e della rottura dei tubi del gas.
A Messina, maggiormente sinistrata, rimasero sotto le macerie ricchi
e poveri, autorità civili e militari. Nella nuvola di polvere che
oscurò il cielo, sotto una pioggia torrenziale ed al buio, i
sopravvissuti inebetiti dalla sventura e semivestiti non riuscirono a
realizzare immediatamente l’accaduto. Alcuni si diressero verso il mare,
altri rimasero nei pressi delle loro abitazioni nel generoso tentativo
di portare soccorso a familiari ed amici. Qui furono colti dalle
esplosioni e dagli incendi
causati dal gas che si sprigionò dalle tubature interrotte. Tra
voragini e montagne di macerie gli incendi si estesero, andarono in
fiamme case, edifici e palazzi ubicati nella zona di via Cavour, via
Cardines, via della Riviera, corso dei Mille, via Monastero
Sant'Agostino.
Ai danni provocati dalle scosse sismiche ed a quello degli incendi si aggiunsero quelli cagionati dal maremoto, di impressionante violenza, che si riversò sulle zone costiere di tutto lo Stretto di Messina con ondate devastanti stimate, a seconda delle località della costa orientale della Sicilia, da 6 m a 12 m di altezza. Pellaro, frazione di Reggio Calabria). Lo tsunami in questo caso provocò molte vittime, fra i sopravvissuti che si erano ammassati sulla riva del mare, alla ricerca di un'ingannevole protezione. Improvvisamente le acque si ritirarono e dopo pochi minuti almeno tre grandi ondate aggiunsero al già tragico bilancio altra distruzione e morte. Onde gigantesche raggiunsero il litorale spazzando e schiantando quanto esistente. Nel suo ritirarsi la marea risucchiò barche, cadaveri e feriti. Molte persone, uscite incolumi da crolli ed incendi, trascinate al largo affogarono miseramente. Alcune navi alla fonda furono danneggiate, altre riuscirono a mantenere gli ormeggi entrando in collisione l’una con l’altra ma subendo danni limitati. Il villaggio del Faro a pochi chilometri da Messina andò quasi integralmente distrutto. La furia delle onde spazzò via le case situate nelle vicinanze della spiaggia anche in altre zone. Le località più duramente colpite furono Pellaro, Lazzaro e Gallico sulle coste calabresi; Briga e Paradiso, Sant'Alessio e fino a Riposto su quelle siciliane. Gravissimo fu il bilancio delle vittime: Messina, che all’epoca contava circa 140.000 abitanti, ne perse circa 80.000 e Reggio Calabria registrò circa 15.000 morti su una popolazione di 45.000 abitanti. Secondo altre stime si raggiunse la cifra impressionante di 120.000 vittime, 80.000 in Sicilia e 40.000 in Calabria. Altissimo fu il numero dei feriti e catastrofici furono i danni materiali. Numerosissime scosse di assestamento si ripeterono nelle giornate successive e fin quasi alla fine del mese di marzo 1909.
Numerose furono le costruzioni vittima dei danni del terremoto e delle successive demolizioni:
A Messina la imponente Palazzata o Teatro marittimo,
lunghissima teoria di palazzi senza soluzione di continuità affacciata
sul porto (opera seicentesca dell'architetto Simone Gullì e poi
ricostruita, dopo il terremoto del 1783, dall'architetto Giacomo Minutoli); il ricchissimo Palazzo Municipale, opera seicentescaGiacomo Del Duca, incluso nella Palazzata; il palazzo della Dogana, costruito sui resti del Palazzo reale, a sua volta crollato nel terremoto del 1783; tantissime chiese, tra cui quella di San Gregorio, nella parte collinare della città sopra la via dei Monasteri (oggi via XXIV Maggio), quella della SS. Annunziata dei Teatini, opera di Guarino Guarini e la cattedrale dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore, ricostruita nel XVI secolo da Carlo V alla foce del torrente Annunziata, sul posto dell'attuale Museo regionale; il Duomo,
ricostruito poi dall'architetto Valenti secondo le linee presunte
dell'originaria struttura normanna e molti edifici pubblici; la sede
della storica Università, fondata come primo collegio gesuitico al mondo nel 1548.
Secondo alcuni studiosi, il DNA degli abitanti dello Stretto è stato modificato dal radon, un gas radioattivo comunemente presente in natura, che aumenta di concentrazione in caso di terremoto.
- Dettagli
- Categoria: Arte e cultura
Inizialmente costruito dalla ditta Pontificia Fabbrica D' Organi Giovanni Tamburini nel 1948 l' Organo del Duomo di Messina possedeva ben 5 manuali di 61 note, un pedaliere concavo con 32 tasti,127 registri reali per 10000 canne divise in quattro distinti corpi d'organo. La disposizione fonica venne curata da Raffaele Manari che inaugurò lo strumento presentado una sua opera; la Fantasia Siciliana. Venne distrutto totalmente dagli eventi bellici che colpirono la città durante il secondo conflitto mondiale. L'attuale organo, sempre costruito dalla stessa ditta, è il secondo più grande d'Italia ed uno tra i più grandi al mondo.
Il progetto fonico è stato redatto secondo uno schema sinfonico eclettico da Ferruccio Vignanelli.
L’Organo è diviso in sei corpi dislocati quasi tutti nel transetto
tranne l’ Organo Eco sistemato a circa 60 metri dalla consolle. Una vera opera d'arte tra le più rinomate al mondo ma allo stesso tempo poco pubblicizzata ed oscura ai più.
- Dettagli
- Categoria: Arte e cultura
Altri pezzi preziosi sono:
- Braccio reliquiario di San Marciano, primo vescovo di Siracusa, donato dal vescovo Richard Palmer nel XII secolo.
- Reliquiario del Sacro Capello di Maria del XIV secolo, contenente il capello con il quale, secondo la tradizione, la Madonna legò il rotolo della Lettera inviata ai messinesi.
- Reliquiario di San Nicola, in argento a forma di braccio benedicente, del XV secolo.
- Reliquiario di San Paolo, in argento, anch'esso a forma di braccio, risalente al XVII secolo.
- Calice d'argento dorato del XIV secolo.
- Calice d'argento dorato, dono dell'Arcivescovo mons. Filippo Crispo (morto nel 1402).
- Pigna in cristallo di rocca, lampada d'epoca araba. Serviva per contenere le reliquie della Madonna nelle processioni.
- Dettagli
- Categoria: Arte e cultura
Altri articoli …
Pagina 1 di 2









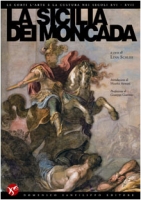

 Home Page
Home Page