Curiosità dal Web - LarderiaWeb
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Incredibile ma vero.... Da una statistica presentata
dall' Atlante socioeconomico della Sicilia realizzato dall'Ufficio
regionale dell'Istat in collaborazione con il servizio Statistica della
Regione che è stato esposto dall'assessorato regionale al Bilancio risulta che circa il 30% dei siciliani ha una seconda casa.
Valori superiori alla media regionale per Agrigento (39,1%), Ragusa
(38%), Trapani (34,9%) ed Enna (31,3%); la graduatoria si chiude con
Catania che presenta una quota pari al 23,6%. Nell'ultimo
decennio le maggiori perdite relative in termini di popolazione sono
state in prevalenza a carico delle aree più interne della regione:
flessioni più marcate si registrano infatti per Enna con un valore pari
a -15%, seguita da Caltanissetta (-7,2%), Agrigento (-5,8%) e Messina
(-3,9%); Catania con +7,6% e Palermo con +4,7% registrano le
performance migliori in considerazione anche della crescente presenza
della componente straniera (il corrispondente dato medio per l'intera
Isola è pari all'1,6%).Il tasso medio di natalità dell'isola è
pari al 10,1 per mille abitanti e risulta convergente sul livello medio
nazionale (9,6 per mille): valori superiori alla media regionale si
registrano per le province di Caltanissetta, Palermo e Catania mentre a
Messina nascono poco più di 8 bambini ogni mille abitanti.
Incredibile ma vero.... Da una statistica presentata
dall' Atlante socioeconomico della Sicilia realizzato dall'Ufficio
regionale dell'Istat in collaborazione con il servizio Statistica della
Regione che è stato esposto dall'assessorato regionale al Bilancio risulta che circa il 30% dei siciliani ha una seconda casa.
Valori superiori alla media regionale per Agrigento (39,1%), Ragusa
(38%), Trapani (34,9%) ed Enna (31,3%); la graduatoria si chiude con
Catania che presenta una quota pari al 23,6%. Nell'ultimo
decennio le maggiori perdite relative in termini di popolazione sono
state in prevalenza a carico delle aree più interne della regione:
flessioni più marcate si registrano infatti per Enna con un valore pari
a -15%, seguita da Caltanissetta (-7,2%), Agrigento (-5,8%) e Messina
(-3,9%); Catania con +7,6% e Palermo con +4,7% registrano le
performance migliori in considerazione anche della crescente presenza
della componente straniera (il corrispondente dato medio per l'intera
Isola è pari all'1,6%).Il tasso medio di natalità dell'isola è
pari al 10,1 per mille abitanti e risulta convergente sul livello medio
nazionale (9,6 per mille): valori superiori alla media regionale si
registrano per le province di Caltanissetta, Palermo e Catania mentre a
Messina nascono poco più di 8 bambini ogni mille abitanti.
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Quante volte avete sentino un cognome particolare che, legato ad un nome, ci fa pensare... ma come si fà a chiamarsi così; i genitori non hanno pensato che quella povera creatura potesse subire le angherie di compagni di classe, amichetti e, addirittura, colleghi di lavoro? Bhooo... eccone un paio veramente comici....
Quante volte avete sentino un cognome particolare che, legato ad un nome, ci fa pensare... ma come si fà a chiamarsi così; i genitori non hanno pensato che quella povera creatura potesse subire le angherie di compagni di classe, amichetti e, addirittura, colleghi di lavoro? Bhooo... eccone un paio veramente comici....
PISCIA Chiara
PISCIA Tranquilla
PISCIA Rosa
PISCIA Antonia (detta Tina)
Felice EVACUO
BISOGNIN Marino
ODORE Celestino
Eros PELOSO
Bambina GOBBA
STRANO Concetto
Massimo INGEGNO
SARAI Primo
SARAI Felice
ERI Fortunato
IERI Selvaggio
CORNA Fedele
CAMERA Daria
TROMBA Daria
TROMBA Marina
Massimo VOLTAGGIO
Luce SCALA
Guido PIANO
Guido DI RADO
Guido COLLAUTO
Guido LA BARCA
Remo LA BARCA
Remo FELICE
ADESSO Ribalta
RULLO Mariagiovanna
Venera LA VITA
Strato INSIDIOSO
DANIELE Killer
Felice MASTRONZO (ha cambiato cognome in Mastranzo)
BUDINO Giannino
COZZA Tina
PATTUME Altero
BIONDO Bruno
PRIMITIVO Biondo
PRIMITIVO Premio
PRIMITIVO Vito
PRIMITIVO Vero
SACRIPANTE Dante
CALCIO GIOVANDO Vanda
BASTARDO DIAZ Lourdes
PORCO PESCE Eva
Vita MAIALE
BRONTOLONE Procolo
GIRA Crocefisso
BALLA Ferdinando (detto Nando...)
FALLA Idolo
FALLA Felicia
CHIESA Chirieleison
MOTIVETTO Pasquale
MUSICA Divina
FORESTA Selvaggia
PORTA Pio
SCHEDA Bianca
CAMISA Bianca
CASETTA Bianca
SALA Bianca
FARINA Bianca
FARINA Fina
PIZZA Margherita
PIZZACALLA Margherita
MELA Marzia
Vera PAGNOTTA
BEVILACQUA Chiara
ACQUA FRESCA Daniela
DAL CALDO Alfredo
COSTA Smeralda
Petra SASSO
PIRLA Abbondanza
NANO Felice
RUSSO Felice
ACETO Genuino
CASTAGNA Vera
CICORIA Bianca
LASAGNA Emiliana
MANGIONE Felice
Gustavo LA PASTA
Gustavo CREMA
Diamante SERIO
PAGELLA Scolastica
PISTONE Catena
Paola PIOLA
Franco FORTE
FOGLIO Rosa
VIOLA Rosa
VIOLA Bianca
Azzurra ROSEA
Bianca LA VERDE
LA SCALA Azzurra
BALOCCO Felice
Santa IENA
Grazia STRAZIO
Grazia DANZANTE
D'ITALIA Ginevra
COLLOCA Bianca
CALZONE Lana
CAMELIA Pasquale
Santo CERVELLO
Gelsomino MALATO
Felice NOSTALGINI
FIOCCO Rosa
CHIAPPA Rosa
Giuseppe (Pino) SILVESTRE
Amabile CUSCINO
CANDELA Aladino
CARA Maria Bambina
Santa PAZIENZA
Bella PARLAPIANO
LA FATA Rosa
LICENZIATO Assunto
MANNO Assunta
Italia Libera REDENTA
DEL MONTE Bianco
MONTE Rosa
DELL'ORTO Fiorito
CARRETTO Agricolo
CAMPO Fiorito
COLTIVATO Fiorito
Fiore CONTRAFATTO
GIGLIOBIANCO Viola
BUTTACAVOLI Agricolo
SPARGISALE Marino
QUERCIA Pino
Fiore SECCO
ABETE Pino
Rosa SPINOSA
BELFIORE Violetta
{mosgoogle center}
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
Natale menzu friddu
Gli altri episodi:
1 episodio Stellario a Taormina
2 episodio Lunedì di Pasqua
3 episodio L' Autobbusso
4 episodio La Paura fa scantare
{mosgoogle center}
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Uno
tsunami è un treno d’ onda, o serie di onde, generata in un corpo di
acqua da un impulso repentino che ne sposta verticalmente una colonna.
I
terremoti, le frane, le eruzioni vulcaniche, le esplosioni e perfino
l'effetto degli enti cosmici, quali la caduta di un meteorite, possono
generare lo tsunami.
Uno
tsunami è un treno d’ onda, o serie di onde, generata in un corpo di
acqua da un impulso repentino che ne sposta verticalmente una colonna.
I
terremoti, le frane, le eruzioni vulcaniche, le esplosioni e perfino
l'effetto degli enti cosmici, quali la caduta di un meteorite, possono
generare lo tsunami.
Tsunami
è una parola giapponese che significa “Onda del porto” ed è
rappresentato da due caratteri, "tsu", significa il porto, il "nami", significa "onda." (tsu-nami).
Tsunami è un termine entrato in uso, soltanto recentemente.
In
passato, per definire il fenomeno degli tsunami, si diceva comunemente
che si era verificata una “eccezionale ondata di marea” o
“maremoto”.
Bisogna chiarire subito che lo tsunami è un fenomeno
diverso dalle maree, benché il suo effetto sulla costa possa essere
influenzato dal livello della marea.
Infatti le maree sono un
fenomeno ciclico, frequente provocato dall’attrazione
gravitazionale della luna, del sole e dei pianeti, mentre lo tsunami è
un fenomeno eccezionale e, fortunatamente, abbastanza raro.
Il
termine “onda sismica marina” può indurre in errore perché
suggerisce l’idea che la nascita dello tsunami sia dovuta
esclusivamente ad un terremoto mentre, in realtà, può essere originato
anche da altri fenomeni come frane o meteoriti.
In Italia è in uso anche il termine di “onda anomala”.
Lo tsunami consiste in una serie di onde. L’acqua,
come qualsiasi liquido, tende ad aderire alle pareti che lo contengono
occupando il minor volume possibile del contenitore. La forza di
gravità fa sì che la superficie superiore del liquido, in stato di
quiete o di equilibrio, appaia assolutamente liscia e piatta come
quella visibile in una bacinella colma di acqua lasciata riposare.Se
soffiamo sulla superficie dell’acqua nella bacinella vediamo che si
formano delle onde: ciò è dovuto al fatto che il nostro soffio ha
aumentato la pressione dell’aria in un punto della superficie facendola
abbassare.
L’acqua
che prima occupava il volume momentaneamente liberato dal nostro soffio
si è fa così spazio accumulandosi nella zona circostante e
determinandone un momentaneo innalzamento del livello fin al punto in
cui la forza di gravità non la spinge nuovamente verso il basso.
Nel
“ricadere” l’acqua è soggetta non solo alla gravità ma anche alla
spinta impressa dal proprio peso per cui arresta la sua corsa ad un
livello più basso di quello che aveva nell’iniziale stato di
equilibrio: ciò determina un avvallamento della superficie che
richiamerà altra acqua dalle zone circostanti.
Contemporaneamente,
cessando l'effetto della pressione esercitata dal soffio, l’acqua tende
a tornare ad occupare lo spazio lasciato libero raggiungendo lo stato
di equilibrio iniziale. Tuttavia, nella breve frazione di tempo del
soffio, parte dell’acqua, che ha espulso, si è riversata, per effetto
della gravità, dalla parte opposta del punto di accumulo per cui non è
più immediatamente disponibile per riempire interamente lo spazio che
era stato liberato dal soffio: ciò determina un avvallamento momentaneo
della superficie che richiama a sua volta altra acqua.
Inizia così
il processo di successivi “aggiustamenti”, fatto di “accumuli” e di
“affossamenti” nella superficie dell’acqua, che chiamiamo “onde”, che
con il tempo raggiungerà nuovamente lo stato di equilibrio tornando ad
essere piatta.
Lo stesso fenomeno si manifesta aumentando la
pressione “dal basso” ed è visibile se colpiamo il fondo della
bacinella colma d’acqua: vedremo allargarsi dalla superficie
dell’acqua, esattamente nel punto perpendicolare a quello del fondo sul
quale abbiamo battuto, una serie di onde. In questo caso le onde sono
state generate dall’innalzamento iniziale e dalle successive vibrazioni
del fondo della bacinella, ma la loro meccanica è uguale alle
precedenti.
Da quanto detto è chiaro che il movimento
orizzontale delle onde, che si allargano in cerchi concentrici, è solo
apparente mentre in realtà gli unici spostamenti che si verificano sono
in senso verticale.
Ogni onda, fra i miliardi di miliardi di
onde generate in ogni istante nei liquidi del mondo, ha alcuni elementi
caratteristici che la rendono unica.
Questi elementi sono la sua altezza, la sua lunghezza ed il suo periodo.
L’altezza dell’onda
misura la distanza fisica (in millimetri, centimetri, metri) fra il suo
punto più alto, che si chiama cresta, ed il livello raggiunto dal
liquido in stato di quiete.
La lunghezza dell’onda
misura la distanza fisica (in centimetri, metri, chilometri) fra le
creste (o fra i punti più bassi detti “depressioni”) raggiunti da due
onde successive.
Il periodo dell'onda misura la distanza temporale (in secondi, minuti, ore) che separa in un punto, due diverse creste.
L’onda
di tsunami è diversa dalle onde generate dal vento, che si possono
osservare in un laghetto o su una spiaggia , perché queste sono
caratterizzate da periodi e da lunghezze di onda brevi.
I cavalloni
generati dal vento di una tempesta al largo delle coste italiane, per
esempio, e che si possono osservare su una delle nostre spiagge, si
susseguono l’un l’altro a distanza di pochi secondi e le onde sono
distanti fra loro al massimo qualche decina di metri.
Uno
“ tsunami”, invece, può essere composto da onde distanti fra loro anche
più di 100 chilometri che possono infrangersi sulla costa anche a
distanza di molte decine di minuti fra l’una e l’altra.
Nella
rielaborazione grafica a fianco viene mostrata l’onda di tsunami
generata dal terremoto verificatosi al largo della costa di Sumatra.
La
grafica evidenzia le onde (in rosso la cresta, in blu la depressione) e
la loro posizione nell'oceano a 30 minuti dall'evento.
Gli tsunami hanno una vita ed un comportamento che è distinguibile in tre fasi.La prima fase è quella del cosiddetto “caricamento dell’energia”.Questa
fase corrisponde all’innalzamento repentino di una colonna di acqua a
causa di un terremoto o di altri eventi come frane o meteoriti.La
seconda fase è quella della “trasmissione dell’energia”. L’energia
caricata inizialmente nella colonna di acqua si trasmette, con perdite
minime, all’acqua circostante dando origine alle onde di tsunami che si
allargano dal punto di origine (epicentro)
La terza fase è quella
dello “scaricamento dell’energia”. Le onde di tsunami raggiungono le
coste con una quantità di energia pressoché simile a quella dalla quale
hanno avuto origine e la scaricano repentinamente sui litorali.
Vediamo in dettaglio le singole fasi.
Gli tsunami di origine sismica
Una
delle cause più frequenti degli tsunami sono i terremoti di origine
tettonica che spostano l’acqua sovrastante in modo brusco. I terremoti
di origine tettonica sono un genere particolare di terremoto e sono
associati alla deformazione della crosta terrestre: quando questi
terremoti si manifestano al di sotto del fondo marino, l'acqua
soprastante l’epicentro del terremoto perde la sua posizione di
relativo equilibrio e viene anch’essa mossa bruscamente.
La massa
d’acqua che viene così spostata, per effetto della forza di gravità,
cerca di riguadagnare lo stato di equilibrio iniziale dando vita al
fenomeno ondoso dello tsunami.
I grandi movimenti verticali della crosta terrestre possono avvenire ai contorni della piastre continentali.
Le piastre continentali interagiscono fra loro, slittando e scontrandosi l’una con le altre.
Intorno
ai margini dell'Oceano Pacifico, per esempio, le piastre oceaniche più
dense slittano sotto le piastre continentali in un processo conosciuto
come il “subduzione”: i terremoti generati dalla “subduzione” sono
particolarmente efficaci nella generazione degli tsunami.
Gli tsunami originati dalle frane
L’equilibrio
relativo dell’acqua del mare può essere compromesso però anche da una
improvvisa caduta di materiali come nel caso della frana. L’acqua che
occupava il volume invaso dal materiale di frana viene spostata e
sospinta verso l’alto generando l’onda di tsunami.
Poiché
normalmente i volumi di acqua messi in moto dalla frana sono di modeste
dimensioni in rapporto al mare aperto gli tsunami che hanno questa
origine interessano aree piuttosto limitate ed hanno conseguenze
disastrose solo nelle vicinanze della loro origine od all’interno di
bacini di limitate dimensioni come i laghi e le baie.
La seconda fase può essere definita come quella del “trasferimento dell’energia” ed identifica lo spostamento dell’onda in mare aperto.
L’onda
dello tsunami in mare aperto è sottoposta alle stesse leggi fisiche
delle onde di superficie che osserviamo nei placidi laghetti di
campagna, ma in questo caso le forze sono enormi, ben più potenti di
quelle abbiamo messo in gioco con l’esperimento della bacinella.
Ciò
significa che l’onda dello tsunami è un’onda molto lunga (anche oltre
cento chilometri) e che si muove in un bacino, quello oceanico,
profondo migliaia di metri con un rapporto fra la lunghezza dell’onda e
la profondità marina molto piccolo.
Tutte le onde di superficie si
muovono ad una velocità che è uguale alla radice quadrata del prodotto
dell'accelerazione di gravità (9,8 m/s2) e della profondità dell'acqua.
Ciò
vuol dire, per esempio, che nell'Oceano Pacifico, che ha una profondità
media di 4000 m, le onde dello tsunami possono raggiungere velocità di
circa 200 m/s, cioè oltre 700 chilometri orari.
Oltre a ciò, poiché
la perdita di energia accumulata dall’onda è inversamente proporzionale
alla sua lunghezza, gli tsunami non solo sono velocissimi, ma possono
percorrere anche distanze immense senza indebolirsi in modo
significativo.
Osserviamo
nuovamente la grafica relativa allo tsunami del dicembre 2004 e
consideriamo le diverse lunghezze dell’onda (la cresta è in rosso
mentre la depressione è in azzurro) che si dirige in mare aperto (con
profondità maggiori) verso l’India e dell’onda che si dirige verso la
più vicina costa tailandese.
Si deve notare anche che nello tsunami
diretto verso oriente la cresta dell’onda (in rosso) è anticipata dalla
depressione (in azzurro).
Questa depressione è stata causata
dall’abbassamento del fondo marino speculare a quello subito nel
versante occidentale opposto, che ha dato origine, invece, ad un
innalzamento della superficie marina (in rosso).
Sappiamo
già che lo tsunami viaggia ad una velocità che è collegata con la
profondità dell'acqua, quindi avvicinandosi alla costa, dove le acque
sono meno profonde, lo tsunami rallenta.
Come abbiamo già capito, lo tsunami accumula l’energia potenziale sia sotto forma di velocità che di altezza dell’onda.
Rallentando a causa delle variazioni nel rapporto che determina la velocità delle onde, che ricordiamo essere:
velocità dell’onda = radice quadrata di [accelerazione di gravità (9,8 m/s2) per profondità dell'acqua]
senza
cioè le perdite di energia causate ad esempio dagli attriti, l’energia
accumulata sotto la forma di “velocità” viene trasferita a quella
accumulata sotto la forma di “altezza” dell’onda.
A causa di questo effetto un’onda di tsunami, impercettibile in mare, aumenta la sua altezza avvicinandosi al litorale.
La terza fase della vita dell’onda di tsunami è quella del “rilascio dell’energia” ed identifica il suo comportamento in prossimità della costa.
Quando
la profondità del fondo marino, in prossimità della terra ferma,
incomincia ad interagire maggiormente con gli attriti l’onda diventa
instabile, la sua cresta tende a ricadere in avanti, innescando una
turbolenza che dissipa una parte dell’energia accumulata.
Questo
rallentamento del fronte dell’onda innesca a sua volta una sorta di
“tamponamento a catena” dove l’acqua retrostante si “scontra” con
quella che la precede più lentamente.
In questo momento la
turbolenza dell’onda è massima e dissipa molta della energia accumulata
che, malgrado ciò, rimane elevatissima abbattendosi sulla costa.
Lo
tsunami ha un grande potenziale erosivo capace di cancellare spiagge
secolari e distruggere la vegetazione, inondare per centinaia di metri
i territori costieri abbattendo costruzioni ed infrastrutture.
L’Onda di tsunami abbattendosi sulla costa può raggiungere un'altezza anche di 30 metri.
Le
dimensioni dell'onda mostrate dalla grafica sottostante sono state
esasperate per rendere visibile nel suo insieme il fenomeno che, nelle
prime fasi di vita, risulterebbe impercettibile.
Dopo che un'onda di tsunami si è abbattuta sulla costa, il riflusso dell'acqua verso il mare provoca una fortissima risacca che può essere anche più pericolosa dell'onda stessa.In qualche caso, all'onda di tsunami segue il fenomeno dello "spiaggiamento": la linea della battigia arretra lasciando scoperte ampie zone del fondo marino normalmente coperte dalle acque.
Lo stesso fenomeno si presenta qualora la cresta dell'onda di tsunami sia preceduta dalla sua depressione che richiama, con una fortissima risacca, l'acqua antistante: l'arretramento della linea della battigia può essere un significativo segno premonitore dell'arrivo di una onda di tsunami.
Come si è visto le onde di tsunami perdono energia in prossimità della costa: una parte dell'energia dell'onda è riflessa verso il mare aperto, mentre la restante è dissipata con l’attrito e la turbolenza sul fondo marino che diventa sempre più basso.
Le onde riflesse verso il mare aperto ripetono, con minore energia, il ciclo di vita dello tsunami andando ad interessare coste già battute dall’onda principale o nuovi litorali. Nella simulazione grafica dello tsunami del dicembre 2004 questo fenomeno, che può durare anche molto a lungo, è ben visibile nel tratto di mare che separa l’isola di Sumatra dalla Thailandia dove onde di tsunami si sono ripetute per molte ore.
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
Il Terremoto è uno dei fenomeni naturali che, più di ogni altro nei secoli, ha avuto il potere di atterrire l'uomo. La terra, ritenuta dall'esperienza comune come un riferimento stabile e sicuro, improvvisamente incomincia a tremare gettando nello sconforto chi assiste impotente al fenomeno.
Da dove nascono questi tremori? E' quanto cercheremo di spiegare in questa pagina.
La terra su cui posiamo i piedi (detta "crosta"), che a noi appare ferma e stabile, in realtà galleggia, come un iceberg nell'oceano, su un mare di roccia fusa (detto mantello) che occupa le parti più profonde del globo. Per effetto di questo "galleggiamento", spinte dalle correnti del "mantello" le grandi masse dei continenti si muovono venendo a contatto le une con le altre. Ovviamente si tratta di movimenti lentissimi rilevabili soltanto attraverso sofisticati strumenti scientifici.
Le rocce della "crosta" sono dunque soggette alle fortissime pressioni necessarie a provocarne lo spostamento ed a vincere la resistenza opposta da altre aree della "crosta" che sono sospinte in senso opposto. Quando questa resistenza si fa più ostinata la roccia della porzione di "crosta" in movimento viene fermata ed incomincia a comprimersi accumulando energia: è come se lentamente venisse compressa una molla. Le rocce continueranno ad accumulare energia fin quando, superato il loro limite elastico, raggiungeranno il "punto di rottura": in quell'attimo, venendo a cadere ogni resistenza, tutta l'energia accumulata viene rilasciata in un istante consentendo un brusco movimento delle rocce. E' questo movimento che da origine alle onde sismiche.
La stessa cosa avviene quando una zona della "crosta" viene trascinata dalle correnti del "mantello" in una direzione opposta alle altre: in questo caso la roccia tenterà di stirarsi nelle due direzioni opposte (come una corda a cui sia stato legato un peso eccessivo) fin quando non raggiungerà il suo limite elastico rompendosi e dando origine ad un terremoto.
Nella illustrazione a lato viene mostrata una porzione di crosta terrestre sottoposta a forze contrastanti: le frecce rosse e le frecce verdi indicano le direzioni verso cui spingono le forze opposte.
In un primo momento le due forze riescono a mantenersi in equilibrio comprimendo le rocce ed accumulando energia elastica. Improvvisamente, raggiunto il limite, le rocce si spaccano e la porzione di crosta si divide in due sezioni che procedono in senso opposto.
In questo caso è nata una FAGLIA, ovvero una frattura nella crosta. La situazione rimarrà in questo stato di equilibrio fin quando le due forze opposte non avranno accumulato sufficiente energia elastica per ripetere il fenomeno.
La nascita improvvisa di una faglia, od il suo improvviso movimento sono dunque una delle cause di terremoto.
Queste fratture (faglie) solo raramente interessano la superficie terrestre: quasi sempre si manifestano a diversi chilometri di profondità.
Il punto d'origine del terremoto, posto in profondità, viene detto ipocentro mentre epicentro è il punto (solitamente posizionato sulla sua verticale) ad esso corrispondente sulla superficie terrestre.
Si è visto che le rocce, nonostante la loro apparenza, godono di proprietà elastiche ed è proprio per queste proprietà elastiche che vengono trasmesse le onde sismiche.
Ogni terremoto da origine a tre tipi di onde sismiche.
Un tipo, detto "onde Longitudinali od onde P" è costituito da onde di compressione del tutto simili a quelle acustiche.
L'illustrazione a lato mostra la rappresentazione di questo tipo di onde: le rocce vengono compresse (colore scuro) e poi dilatate (colore chiaro) nella stessa direzione del loro movimento.
L'animazione a lato mostra la rappresentazione di questo tipo di onde: le rocce vengono compresse (colore scuro) e poi dilatate (colore chiaro) nella stessa direzione del loro movimento. Tutto questo si traduce, sulla superficie terrestre, nel rapido innalzamento ed abbassamento del suolo che vibra con un movimento che viene definito "sussultorio".
Qualunque tipo di terreno è in grado di trasmettere "Onde P".
Un secondo tipo è quello detto delle "onde Trasversali o di scuotimento od onde S".
Questo tipo di onde si comporta come una corda di violino quando viene pizzicata.
Le vibrazioni originate in un punto della corda si trasmettono al suo capo opposto attraverso oscillazioni perpendicolari al senso del moto.
In modo analogo le onde S progrediscono nel terreno, comprimendo e dilatando le rocce perpendicolarmente alla direzione d'avanzamento, dando vita a vibrazioni della superficie terrestre di tipo "ondulatorio".
Le onde S si trasmettono esclusivamente nei corpi solidi. E' per questo motivo che, non trasmettendosi le onde S attraverso il centro della Terra, il nucleo del globo viene ritenuto allo stato liquido.
Infine vi è un tipo di onde, detto di Superficie od onde L, che si manifesta sulla superficie della crosta in modo analogo a quello delle onde dei corpi liquidi.
Queste onde sono l'effetto in superficie del transito delle onde P e delle onde S.
Le cosiddette onde L sono il tipo più comune di onde di superficie.
Altri tre tipi di onde di superficie rappresentano combinazioni dei tipi di onde esaminati in precedenza.
Dato uno sguardo ad alcune delle cause di origine dei terremoti ed al modo con cui si sviluppano le onde sismiche proviamo a individuare i loro effetti in superficie.
Le vibrazioni del suolo, al passaggio di un'onda sismica, si trasmettono a tutto quanto vi è ancorato.
La vibrazione è un rapido spostamento di un corpo in una direzione ed il suo successivo spostamento nella direzione opposta.
Immaginiamo che un grattacielo venga colpito da un'onda di compressione che procede verso sinistra.
Il grattacielo, trascinato dal terreno, avanzerà verso sinistra ma dovrà vincere la resistenza dell'aria contro la parete sinistra mentre la parete opposta subirà una depressione dovuta alla sua rarefazione.
Non appena passata la compressione il terreno tenderà a ritornare nella posizione originaria (fase di espansione) trascinando con se il grattacielo verso destra: sarà allora la parete di destra a dover vincere la resistenza dell'aria mentre quella di sinistra dovrà resistere alla decompressione.
In modo analogo un innalzamento del suolo farà gravare sulla struttura del grattacielo un peso maggiore della norma (in qualche caso si supera lo 0,5 G e cioè il grattacielo peserà una volta e mezzo rispetto al normale) mentre nella fase di abbassamento la sua struttura sarà più leggera.
Questo tipo di movimenti (vibrazioni verso l'alto ed in senso laterale) si ripetono in modo velocissimo al passaggio dell'onda sismica provocando uno stress nei materiali degli edifici che ne può determinare il crollo.
Normalmente i fabbricati sono in grado di sopportare pesi maggiori rispetto al normale, mentre sono in grado di resistere soltanto alla pressione laterale esercitata dai venti (che è molto inferiore a quella esercitata dal terremoto). Ne consegue che, di norma, i fabbricati sono in grado di resistere agli effetti sussultori provocati dalle "Onde P", ma non a quelli ondulatori prodotti dalle "Onde S": saranno queste ultime, dunque, a provocarne l'eventuale crollo.
Tuttavia le "Onde P" (sussultorie) si muovono più velocemente delle "Onde S"(ondulatorie) e raggiungono i fabbricati prima di queste ultime (maggiormente distruttive) "avvertendo" del loro arrivo: dunque esiste sempre un po' di tempo per prepararsi ed approntare le difese.
Sulla base delle osservazioni degli effetti dei terremoti sui manufatti umani, Mercalli elaborò una scala per misurarne l'intensità che venne poi migliorata da studi successivi (Scala MCS):
I GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <0,25 cm/sec² - Viene percepito solo dagli strumenti
II GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <0.50 cm/sec². - Le vibrazioni vengono percepite soltanto da soggetti estremamente sensibili e nervosi ai piani alti dei fabbricati
III GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <1 cm/sec². - Le vibrazioni vengono avvertite da un numero maggiore di persone che si trovano all'interno di fabbricati, ma sono spesso confuse con quelle provocate dal passaggio di un'auto a velocità elevata. Viene identificato come terremoto soltanto dopo averci riflettuto
IV GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <2,5 cm/sec². - solo poche persone che si trovano all'aperto percepiscono le vibrazioni, mentre è maggiormente avvertito da chi si trova in locali chiusi. Le vibrazioni sono simili a quelle prodotte dal passaggio di un pesante autocarro che transiti a breve distanza su un terreno sconnesso.
V GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <5 cm/sec². - Viene facilmente percepito da tutti. Piante e rami deboli dei cespugli vengono mossi come soggetti ad un vento moderato. Gli arredi appesi, leggeri, oscillano mentre i mobili vibrano visibilmente
VI GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <10 cm/sec². - Viene avvertito da tutti con paura. Isolati pezzi di arredo vengono spostati, se non rovesciati. Libri e soprammobili cadono. Le case isolate ben costruite subiscono danni leggeri: spaccature nell'intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e pareti. Gli edifici mal costruiti subiscono danni maggiori, ma non ancora pericolosi. Cade qualche tegola o qualche comignolo. Le campane più piccole di cappelle e chiese rintoccano
VII GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <25 cm/sec². - I mobili subiscono danni notevoli. Le campane più grosse rintoccano. Danni moderati sono causati ad edifici di forte struttura con piccole spaccature nei muri, caduta di toppe d'intonaco e di stucchi. E' possibile il crollo di case mal costruite
VIII GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <50 cm/sec².- Anche i mobili più pesanti vengono spostati lontano dalla loro sede. Lastre e pietre miliari ruotano sul loro asse o sono abbattute. Un quarto della casa è danneggiato, alcune case crollano, altre sono inagibili
IX GRADO MCS- paragonabile ad accelerazioni <100 cm/sec². - Le case in pietra hanno il 50% di probabilità di crollare
X GRADO MCS - paragonabile ad accelerazioni <250 cm/sec². - Circa il 75% degli edifici viene distrutto. Ponti e dighe vengono danneggiati. I binari vengono piegati e le superfici asfaltate possono piegarsi ed ondularsi. Le tubature e le condotte sono piegate, schiacciate o rese inservibili
XI GRADO MCS- paragonabile ad accelerazioni <500 cm/sec² - Tutte le costruzioni umane sono distrutte. Le modificazioni superficiali del terreno sono notevoli ed evidenti
XII GRADO MCS - paragonabile ad accelerazione>500 cm/sec².- Non resiste alcuna opera dell'uomo. Il paesaggio viene modificato con la scomparsa improvvisa di laghi o lo comparsa di nuove cascate
Un altro modo di classificare i terremoti si basa sulla energia liberata (magnitudo) e venne messo a punto da Richter. La Scala Richter fornisce utilissime indicazioni agli studiosi, ma è meno significativa ai fini della semplice autoprotezione.
Altri articoli …
- Teorie e Leggi che hanno cambiato il mondo
- La relatività ristretta di Einstein
- Il secondo principio della termodinamica di Clausius
- La legge dellinduzione elettromagnetica di Faraday
- La legge della pressione idrodinamica di Bernoulli
- La legge della gravitazione universale di Newton
- La Teoria dell'evoluzione delle specie
- La Teoria della relatività
- La Teoria del Big Bang
- Rss Feed. Cosa sono e a cosa servono
Pagina 20 di 76









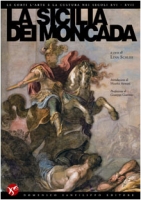

 Home Page
Home Page