Curiosità dal Web - LarderiaWeb
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
Questa idea si sviluppa in seno alla tradizione brahmanica (800 a.C.), molto posteriore alla tradizione vedica (1500 a.C.), e postula la necessità di una rinascita in vite successive quale fio necessario per non aver potuto raggiungere la perfezione nella vita attuale. E’ un abbozzo di teoria reincarnazionista.
In Occidente la teoria reincarnazionista entra grazie alla visione greca della ‘metempsicosi’. L’idea sarà propagandata dagli ‘orfici’, da Pitagora e da Platone. Da quest’ultimo, attraverso i movimenti neoplatonici, giunge alle prime comunità cristiane. Benché negli ambiti cristiani la reincarnazione fosse considerata un’eresia, troviamo tracce dei suoi ‘derivati’ in alcuni scritti di padri della chiesa: Giustino, ad esempio, affermò la preesistenza dell’anima; Clemente Alessandrino fece accenno alla metempsicosi e alla ‘trascorporazione’; anche Origene, nell’intento di conciliare cristianesimo e pensiero platonico, rafforza l’idea della preesistenza dell’anima. Si è ancora lontani dal concetto moderno di reincarnazione, che diverrà più concreto in seno alle correnti manichee e gnostiche. Dopo aver fatto capolino nel pensiero di uomini rinascimentali come Gerolamo Cardano e Giordano Bruno, la reincarnazione diventa dottrina conosciuta grazie ai movimenti spiritista e teosofista dell’800. E qui, l’idea si contorce, si mimetizza, si annacqua e si frantuma dando origine a una gran quantità di credenze che con quella originale non hanno quasi più nulla in comune.
La reincarnazione è veritiera e verificabile, ci dicono, perché
numerosi sono ormai i casi di persone che sotto ipnosi hanno ricordato
frammenti di una vita vissuta precedentemente.
In realtà si parla di ‘dejà vù’. Secondo lo psicologo Christopher Evans:
Ci sono tre modi per spiegare questo fenomeno. Il primo consiste nel ritenerlo…una prova lampante che si sono già vissute altre vite in passato…Si potrebbe tuttavia osservare che se ciò fosse vero, la loro vita precedente doveva essere esattamente uguale a quella presente, dal momento che i luoghi, le situazioni, le persone sono le stesse. Non si tratterebbe quindi di un’altra vita, ma della stessa… Vi è poi una seconda interpretazione: quella di vivere un’esperienza di preveggenza: Ma esiste una terza spiegazione, più semplice: e cioè che il cervello sta producendo un ricordo falso.
Nell’esperienza del ‘ricordo falso’, ci troviamo ad affrontare una
situazione simile ad una vissuta precedentemente (in questa stessa vita
e non in un’altra); il cervello, erroneamente, sovrappone due diversi
vissuti, sperimentati in due momenti diversi, illudendoci di averli
sperimentati già in passato in un’unica situazione.
La Rivelazione biblica contrasta con la teoria della reincarnazione.
Secondo l’Induismo, il ciclo delle reincarnazioni individuali sarebbe
la replica, in piccolo, del “grande ciclo delle creazioni e dei respiri
di Brama”.
Interpretando il concetto con immagini immediate e semplificate,
possiamo dire che il dio indù farebbe, come attività principe,
‘respirazione’; i due movimenti di inspirazione ed espirazione
equivarrebbero ai due poli di un intero ciclo di involuzione ed
evoluzione. Gli stessi poli, esprimerebbero anche l’idea di ‘Assoluto’
e di ‘relativo’: cioè la sfera divina e quella materiale.
In tale visione, il momento dell’involuzione equivarrebbe al passaggio
dal polo dell’assoluto a quello del relativo; il movimento
dell’evoluzione produrrebbe il moto contrario. Quindi, ciclicamente il
divino scenderebbe nel materiale (espirazione, involuzione, Assoluto
nel relativo), per risalire, innalzando e assorbendo in se il materiale
(inspirazione, evoluzione, relativo nell’Assoluto).
Il moto evolutivo libererebbe, a poco a poco, il polo superiore dalle
catene del polo inferiore, sino al suo assorbimento totale
nell’Assoluto primordiale.
In seno al grande ciclo dell’assoluto, supremo, cosmico, abbiamo anche un piccolo ciclo per gli spiriti individuali.
Questo, in grandi linee, il pensiero. Subito alcune considerazioni si
impongono: quale sarebbe, innanzitutto, la forza che produrrebbe questa
‘rotazione ciclica’? E’ essa ‘spirito’ o ‘materia’?
Sappiamo che nella filosofia indù non esiste una differenza essenziale
tra lo stato materiale e quello spirituale, poiché sono considerati
poli e co-principi di una dinamica ciclica. Secondo tale impostazione
di pensiero Dio verrebbe ad essere come il polo di un ciclo; ma nella
dinamica ciclica Dio verrebbe ad essere anche il polo opposto, cioè
smettere di essere Dio. Ma può Dio subire un cambiamento di stato ? Una
dispersione della Sua sostanza? Un raffreddamento del Suo ardore? Una
relativizzazione? E’ forse possibile frantumare Dio; dividerlo in parti
o frazioni?
Se, come afferma il credo indù, la realtà del mondo e quella di Dio
sono la stessa cosa, non risulterà anche che il mondo è una frazione di
Dio?
E se non c’è differenza tra illusorio e reale, non si rischia di
affermare che Dio è ‘multiplo’ e che il mondo è ‘uno’? Ovvero, che
l’identità di Dio con il mondo è la stessa cosa che la non-identita;
che la differenza tra Pietro e Paolo è la loro identità, come la loro
identità è la loro differenza; che un grosso pesce rosso è giallo, e
che uno giallo è rosso; che la verità di una proposizione è uguale alla
sua negazione, e che non ci sono differenze tra il parlare e lo stare
zitti, tra l’essere e il non essere?
Lo stesso concetto di ‘Assoluto’, nella filosofia indù appare come una
contraddizione. Il modo di essere ‘ assolutamente Assoluto’ è quello di
non essere ‘giammai relativamente’. Concepire il mondo sensibile come
un aspetto relativo dell’Essere Assoluto è, di fatto, distruggere la
barriera che separa l’Assoluto dal relativo. Ciò non porta ad una
‘assolutizzazione del relativo’, come si pretende in certi ambienti
reincarnazionisti; porta, invece, a ‘relativizzare l’Assoluto, quindi a
distruggerlo: è la sparizione, l’annullamento di Dio.
Nella Bibbia Dio è “tre volte Santo”; Essere personale, capace di
amare, di volere, di giudicare; separato dalla sua creatura; totalmente
‘Assoluto’; totalmente ‘a parte’.
L’Assoluto induista è un concetto nebuloso, astratto, impersonale, atto
a mascherare e coprire una lacuna enorme che la reincarnazione non può
spiegare, né risolvere. L’Assoluto indù non abita i cieli e la terra
come il Dio della Bibbia; non abita fra gli uomini, come fa Jhaveh; ad
essi si sottrae, e vanisce totalmente qualora lo si voglia osservare
più da vicino.
La legge del karman non prevede opzioni quali ‘peccato’ e ‘giudizio’.
Non esistendo un Dio personale che giudica, non esiste neppure un
giudizio. Non può essere concepito il perdono per il peccato, né
misericordia e comprensione per chi cade vittima delle spire del male;
nessuna redenzione: quindi, nessuna salvezza.
Nell’economia
cristiana le categorie di ‘bene’ e di ‘male’ sono contrapposte e ben
distinte: chi commette peccato, e da esso non si ravvede, è destinato
ad essere giudicato. Il karman, invece, elimina l’idea di Dio,
lasciando l’uomo nell’illusione fatale di essere responsabile non di
fronte ad un codice morale, ma solo di fronte a se stesso. La dottrina
della reincarnazione spinge l’uomo a sentirsi e a farsi dio di se
stesso; esso stesso dio. In tutta la dottrina della reincarnazione,
l’unico assente è proprio Dio.
L’apostolo Paolo afferma:”E’ stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola…apparirà una seconda volta…a quelli che l’aspettano per la loro salvezza”.
Fonte: Luigi Caratelli maran-ata.it
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Il New Age può considerarsi
una via di mezzo fra un nuovo movimento religioso e una nuova credenza. L' età dell'Aquario si contrappone a quella attuale dei Pesci,
caratterizzata da razionalità, conformismo, fanatismo, violenza: l'era
nuova tende invece a valorizzare l'emotività, la visione magica e
olistica del mondo, il corpo, l'energia mentale e spirituale. Dato il fervere di movimenti alternativi sorti nel tardo XX secolo nel mondo occidentale con l'ideale del mondo nuovo, ci si riferisce attualmente col termine New Age
a tali disomogenee realtà (semplici stili di vita, filosofie,
religioni, terapie, organizzazioni, aziende, eccetera) accomunate da un
approccio eclettico e individuale all'esplorazione della spiritualità.
Il New Age può considerarsi
una via di mezzo fra un nuovo movimento religioso e una nuova credenza. L' età dell'Aquario si contrappone a quella attuale dei Pesci,
caratterizzata da razionalità, conformismo, fanatismo, violenza: l'era
nuova tende invece a valorizzare l'emotività, la visione magica e
olistica del mondo, il corpo, l'energia mentale e spirituale. Dato il fervere di movimenti alternativi sorti nel tardo XX secolo nel mondo occidentale con l'ideale del mondo nuovo, ci si riferisce attualmente col termine New Age
a tali disomogenee realtà (semplici stili di vita, filosofie,
religioni, terapie, organizzazioni, aziende, eccetera) accomunate da un
approccio eclettico e individuale all'esplorazione della spiritualità.
 E' un fenomeno che appare inafferrabile, che elude le definizioni e che
avrebbe come caratteristica
principale proprio quella di non poter essere definito, ma
costituirebbe un ambiente, uno stile di vita. Eppure, nonostante l’apparente impossibilità di
circoscrivere una definizione che vada oltre la semplice traduzione
della formula inglese secondo cui tale fenomeno attenderebbe – appunto
– un «Evo Nuovo» o un’«Età Nuova», la riflessione scientifica è
riuscita a produrre negli anni 1990 una serie di risultati
particolarmente convincenti; segnaliamo inoltre come anche il Magistero
cattolico abbia avviato una valutazione globale del fenomeno.
E' un fenomeno che appare inafferrabile, che elude le definizioni e che
avrebbe come caratteristica
principale proprio quella di non poter essere definito, ma
costituirebbe un ambiente, uno stile di vita. Eppure, nonostante l’apparente impossibilità di
circoscrivere una definizione che vada oltre la semplice traduzione
della formula inglese secondo cui tale fenomeno attenderebbe – appunto
– un «Evo Nuovo» o un’«Età Nuova», la riflessione scientifica è
riuscita a produrre negli anni 1990 una serie di risultati
particolarmente convincenti; segnaliamo inoltre come anche il Magistero
cattolico abbia avviato una valutazione globale del fenomeno.
Trattandosi di una realtà fluida e sfuggente – si potrebbe dire di un clima, di un’ambiente, un’atmosfera, un insieme di realtà che hanno fra loro una certa aria di famiglia, ma che presentano anche differenze e contraddizioni –, per favorire una visione globale quanto più fedele possibile, concentreremo la nostra attenzione sul tentativo di una quadruplice definizione di questo fenomeno rispettivamente in una descrizione di natura psicologica, storica, sociologica e dottrinale.
Descrizione psicologica
 Il
New Age può essere anzitutto descritto in chiave psicologica come uno
stato d’animo: come la sensazionecondivisa da un numero socialmente significativo di persone di essere
entrati in un’epoca nuova, che è
contrassegnata da cambiamenti radicali e qualitativi non in uno solo,
ma in tutti i settori della vita dell’uomo. I cambiamenti scientifici dovrebbero provocare
una catena inarrestabile di cambiamenti globali a cui nessun campo di
attività dell’uomo dovrebbe sfuggire.
Il
New Age può essere anzitutto descritto in chiave psicologica come uno
stato d’animo: come la sensazionecondivisa da un numero socialmente significativo di persone di essere
entrati in un’epoca nuova, che è
contrassegnata da cambiamenti radicali e qualitativi non in uno solo,
ma in tutti i settori della vita dell’uomo. I cambiamenti scientifici dovrebbero provocare
una catena inarrestabile di cambiamenti globali a cui nessun campo di
attività dell’uomo dovrebbe sfuggire.
Il filosofo della scienza Thomas Kuhn (1923-1996) sosteneva che quando nella scienza non sono soltanto singole «teorie», ma interi «paradigmi» a cambiare, si determina una «rivoluzione». Il New Age non è solo l’attesa profetica di un’ età nuova né si riduce a un rinnovato interesse per il mondo occulto, esoterico o inconscio, perché ne fanno parte allo stesso titolo movimenti di rovesciamento dei «paradigmi» in campo politico, economico e morale.
 Dal punto di vista astrologico l’idea dell’ evo nuovo (o della «nuova
era») si fonda sulla versione moderna della teoria della precessione degli equinozi, per la quale il sole
cambierebbe di segno zodiacale ogni 2160 anni. L’elaboratore moderno di
questa teoria è stato l’esoterista francese Paul Le Cour (1871-1954), con la sua opera del 1937 L’ Era dell’Acquario. Il segreto dello Zodiaco,
il futuro prossimo dell’umanità, secondo cui l’ Età dei Pesci, iniziata
approssimativamente verso l’anno 1 dopo Cristo, dovrebbe cedere il
passo all’Età dell’Acquario verso l’anno 2160 (in seguito sono stati
proposti altri calcoli e l’ingresso nell’Età dell’Acquario è stata
fissata in numerose date fra il 1920 e il 2300).
Dal punto di vista astrologico l’idea dell’ evo nuovo (o della «nuova
era») si fonda sulla versione moderna della teoria della precessione degli equinozi, per la quale il sole
cambierebbe di segno zodiacale ogni 2160 anni. L’elaboratore moderno di
questa teoria è stato l’esoterista francese Paul Le Cour (1871-1954), con la sua opera del 1937 L’ Era dell’Acquario. Il segreto dello Zodiaco,
il futuro prossimo dell’umanità, secondo cui l’ Età dei Pesci, iniziata
approssimativamente verso l’anno 1 dopo Cristo, dovrebbe cedere il
passo all’Età dell’Acquario verso l’anno 2160 (in seguito sono stati
proposti altri calcoli e l’ingresso nell’Età dell’Acquario è stata
fissata in numerose date fra il 1920 e il 2300).
È appena il caso di ricordare che, su un altro versante, secondo la tradizione della legge dei cicli dell’umanità, che si ritrova nella maggior parte delle grandi civiltà, indiane, greche, egiziane, sumere, indù, cinesi , quest’ultima sarebbe arrivata oggi al punto di passaggio dall’ Età del Ferro all’ Età dell’Oro. La serie di coincidenze cronologiche e l’identificazione del simbolo astrologico dei Pesci con il pesce come simbolo di Cristo – secondo l’acrostico Ix™uß (Ichtús, «pesce»), che dà origine all’invocazione «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore» – rendevano facile l’associazione fra l’Età dei Pesci e l’era cristiana, e la successiva Età dell’Acquario con un era in cui sarebbe apparso qualcosa di radicalmente nuovo rispetto al cristianesimo. Se, come ha osservato lo storico dell’esoterismo Robert Amadou, una serie di autori precedenti avevano influenzato lo schema di Paul Le Cour, va notato come per Le Cour l’Età dell’Acquario sarebbe stata caratterizzata da un nuovo cristianesimo, non più gerarchico sotto il segno di San Pietro, ma spirituale ed esoterico sotto il segno di San Giovanni.
Negli anni 1960 anche le canzoni giovanili cominciarono a inneggiare a questa nuova era:
Armonia, lealtà, chiarezza
Simpatia, luce e verità...
Nessuno ne sopprimerà la libertà!
Nessuno ne imbavaglierà lo spirito!
La mistica ci consentirà di comprendere
E l’uomo imparerà di nuovo a pensare
Grazie all’Acquario! Grazie all’Acquario!
Descrizione storica
 Il New Age si pone come movimento di risveglio, nell’area
culturale di lingua inglese, non più del mondo cristiano ma del mondo
laico se non laicista.Gli ambienti massonici e
teosofici, in particolare, denunciavano una preoccupante incapacità di
interpretare i tempi e di svolgere il consueto ruolo di organizzazione
culturale. Nel mondo teosofico il disagio si era tradotto in una serie
di scismi, il più rilevante dei quali era stato promosso da Alice
Bailey (1880-1949).
Il New Age si pone come movimento di risveglio, nell’area
culturale di lingua inglese, non più del mondo cristiano ma del mondo
laico se non laicista.Gli ambienti massonici e
teosofici, in particolare, denunciavano una preoccupante incapacità di
interpretare i tempi e di svolgere il consueto ruolo di organizzazione
culturale. Nel mondo teosofico il disagio si era tradotto in una serie
di scismi, il più rilevante dei quali era stato promosso da Alice
Bailey (1880-1949).
Già nel 1962, che può essere ritenuta la data più convincente della nascita del fenomeno New Age come oggi lo conosciamo, era stato fondato a Esalen, in California, un centro di incontri e seminari ispirato a simili princìpi; e sempre dagli Stati Uniti arrivò a Findhorn David Spangler, il quale contribuì non poco a far conoscere questa nuova realtà nel continente americano attraverso la pubblicazione dei più influenti manifesti del New Age durante gli anni 1970, favorendo così la successiva diffusione e successo su scala mondiale di una realtà originariamente nata in Europa.
Descrizione sociologica
 Anche nell’ambito
sociologico questa nuova realtà della galassia neo-religiosa pone diversi problemi, anzitutto
perché non si presta a essere inquadrata facilmente in nessuna della
categorie interpretative normalmente utilizzate per i fenomeni della
nuova religiosità contemporanea (nuove religioni, nuovi movimenti
religiosi, nuovi movimenti magici).
Per facilitare la comprensione
del fenomeno si è fatto dunque riferimento a una categoria indicata con il termine network.
Anche nell’ambito
sociologico questa nuova realtà della galassia neo-religiosa pone diversi problemi, anzitutto
perché non si presta a essere inquadrata facilmente in nessuna della
categorie interpretative normalmente utilizzate per i fenomeni della
nuova religiosità contemporanea (nuove religioni, nuovi movimenti
religiosi, nuovi movimenti magici).
Per facilitare la comprensione
del fenomeno si è fatto dunque riferimento a una categoria indicata con il termine network.
Difficile comprendere che cos’è un network o «struttura a rete». I movimenti sono sistemi sociali con un minimo di struttura, una gerarchia riconoscibile, punti di riferimento sul territorio e nella società quali sedi, giornali, attività che seguono un programma preciso, e così via. I movimenti possono essere politici, culturali, religiosi; benché la magia sia stata considerata a lungo un’attività prevalentemente individuale, sono emersi specialmente nell’ultimo secolo anche gruppi che si possono chiamare «nuovi movimenti magici». Tuttavia, le persone che si riuniscono per condividere interessi comuni non formano necessariamente un movimento.
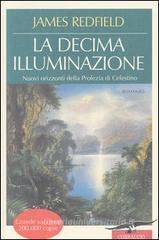 Può trattarsi
di cerchie amicali molto più informali, che mancano di quel minimo di
struttura necessario perché si possa parlare di «movimento», nel senso
in cui questo termine è utilizzato nelle scienze sociali contemporanee.
Se un gruppo di appassionati di astrologia si incontra periodicamente
per mettere in comune le proprie idee, non si può ancora parlare di
movimento. Da questi contatti, evidentemente, può
nascere un movimento che si dota di strutture e di gerarchie. Ma i
contatti possono anche rimanere informali, e può accadere che si voglia
tematicamente evitare il formarsi di gerarchie e di strutture.
Può trattarsi
di cerchie amicali molto più informali, che mancano di quel minimo di
struttura necessario perché si possa parlare di «movimento», nel senso
in cui questo termine è utilizzato nelle scienze sociali contemporanee.
Se un gruppo di appassionati di astrologia si incontra periodicamente
per mettere in comune le proprie idee, non si può ancora parlare di
movimento. Da questi contatti, evidentemente, può
nascere un movimento che si dota di strutture e di gerarchie. Ma i
contatti possono anche rimanere informali, e può accadere che si voglia
tematicamente evitare il formarsi di gerarchie e di strutture.
Se continueranno a mancare
elementi di struttura e di gerarchia, ci si troverà di fronte a un
network.
I network hanno spesso bisogno di servizi: libri, oggetti, qualcuno che si occupi di organizzare momenti d’incontro e riunioni. È facile che un network, soprattutto se nuovo, si appoggi ad altri network esistenti per condividerne in qualche modo le risorse, se non altro per ragioni di economia. Questi network sono affini fra loro anche perché è probabile che un certo numero di persone coltivi con sufficiente continuità non uno solo ma due o più fra questi vari interessi e partecipi quindi contemporaneamente a vari network. Fra diversi network, che hanno fra loro un certo grado di affinità, nasce così un «network di network», che è stato chiamato metanetwork.
 "Si
tratta di un metanetwork particolare, cresciuto a dismisura perché –
grazie all’atteggiamento psicologico che costituisce il New Age [...] –
il metanetwork New Age può inglobare un gran numero di network diversi,
accomunati dall’idea secondo cui sono in corso, o sono prossime, novità
qualitative e radicali: così ai festival, alle riunioni, ai centri
d’incontro del New Age possono partecipare membri di network tanto
diversi fra loro come l’ecologia, il pacifismo, le medicine orientali,
l’occultismo e la credenza nei messaggi trasmessi da extraterrestri. Ma il metanetwork rimane un network e non un movimento: continua a non
avere forme di appartenenza rigide, né capi, né un’organizzazione
gerarchica stabilita in modo articolato sul territorio. Le strutture –
che non mancano – sono strutture di servizio – che si occupano, per
esempio, della vendita per corrispondenza di libri e di altri prodotti
– piuttosto che strutture di appartenenza".
"Si
tratta di un metanetwork particolare, cresciuto a dismisura perché –
grazie all’atteggiamento psicologico che costituisce il New Age [...] –
il metanetwork New Age può inglobare un gran numero di network diversi,
accomunati dall’idea secondo cui sono in corso, o sono prossime, novità
qualitative e radicali: così ai festival, alle riunioni, ai centri
d’incontro del New Age possono partecipare membri di network tanto
diversi fra loro come l’ecologia, il pacifismo, le medicine orientali,
l’occultismo e la credenza nei messaggi trasmessi da extraterrestri. Ma il metanetwork rimane un network e non un movimento: continua a non
avere forme di appartenenza rigide, né capi, né un’organizzazione
gerarchica stabilita in modo articolato sul territorio. Le strutture –
che non mancano – sono strutture di servizio – che si occupano, per
esempio, della vendita per corrispondenza di libri e di altri prodotti
– piuttosto che strutture di appartenenza".
Descrizione «dottrinale»
 Dal
punto di vista dottrinale offrire una descrizione del New Age sembra
particolarmente difficile, tanto più che i suoi promotori si fanno
premura normalmente di spiegare che il New Age non è né ha una
«dottrina».
Dal
punto di vista dottrinale offrire una descrizione del New Age sembra
particolarmente difficile, tanto più che i suoi promotori si fanno
premura normalmente di spiegare che il New Age non è né ha una
«dottrina».
Volendo perseguire una descrizione di
tipo dottrinale, si dovrebbe piuttosto insistere su un principio di
carattere epistemologico, cioè su una forma particolare di relativismo. L’idea secondo cui non
esiste la verità è purtroppo antica quanto l’uomo. Il relativismo del New Age sostiene
non soltanto che ognuno di noi ha la sua verità, ma che ognuno di noi
può letteralmente creare la sua realtà, di cui quindi sarà autorizzato
a porre i criteri di verità e le leggi. Effettivamente, nel parlare di
una «visione del mondo» del New Age vi è qualcosa di paradossale, forse
di provocatorio, visto che i portavoce dello stesso affermano
tenacemente che lo specifico del fenomeno è l’assenza di una visione
del mondo e di qualsivoglia dottrina.
E' possibile ricondurre sei temi principali, esplorati più ampiamente nell’opera Storia del New Age 1962-1992 (pp. 85-120), quella trama di fondo costitutiva della «dottrina» del New Age:
• la premessa necessaria per qualunque «visione
del mondo» del New Age è, come abbiamo detto, di carattere
epsitemologico: non esistono verità assolute;
• un secondo elemento
comune è una diffidenza nei confronti dell’idea di «religione»,
sostituita dalla più vaga «spiritualità»;
• per quanto riguarda il concetto di Dio, di cui il New Age parla
volentieri, non si tratta di un Dio personale, ma piuttosto di un
sottofondo cosmico, di un’energia cosmica immanente;
• la visione dell’uomo si riassume nel noto slogan dell’attrice Shirley
MacLaine – che da anni svolge il ruolo di missionaria internazionale
del New Age –: «Noi siamo Dio»;
• relativamente a Gesù Cristo, il New Age preferisce riferirsi a «il
Cristo», quella scintilla divina che è in ciascuno di noi e che può
essere risvegliata attraverso la molteplicità di tecniche che il New
Age insegna;
• il sesto tema unificante è il rifiuto della nozione di peccato,
sostituita da quella di malattia, che può essere superata con un
generale cambiamento di coscienza che risolverà i problemi del mondo.
Questo studio è stato tratto dal tascabile
“New Age”, ed. AdV, Falciani Imprunete (Fi). Fonte : maran-ata.it
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Chi va fuori, fa fortuna o, sicilianizzato, Cu nesci arrinesci. Lo scrive Gaetano Savatteri, nel libro I Siciliani, che “in
dialetto la frase assume ambiguo significato: da una parte, a voler
dire che in condizioni di vita meno soffocanti, in contesti più sereni,
il siciliano riesce a esprimere le proprie virtù e il proprio talento;
dall’altra, la frase è non solo l’alibi per i fallimenti o gli
insuccessi di chi ha preferito o ha dovuto rimanere in Sicilia, ma
nello stesso tempo la conferma che il senso di sé di ogni siciliano è
tale da non permettere a nessun altro di primeggiare”. Tutte occupazioni che non prevedono un fisso ma un
compenso a provvigioni sono in Sicilia. E si può andare avanti così? Certo che no, ma in sicilia non esiste qualcosa di duraturo, un lavoro che
possa permettere di guardare il futuro negli occhi. Ed in Sicilia ciò
non può accadere. Diceva Leonardo Sciascia: né con te né senza di te. Si sa che la vita è difficile per tutti, sia al Sud sia al
Nord, ma Milano non è Palermo; Torino non è Trapani; Verona non è
Agrigento; Bologna non è Messina. Potete dirmi che è difficile
dappertutto trovare lavoro, che la vita è più cara in Lombardia che in
Sicilia, però vi assicuro che nell’isola e nessuno fa
niente per migliorare la situazione, perché c’è a chi conviene.
Qui un giovane, senza amicizie di un certo peso, non ha alcuna
possibilità di farsi una famiglia ed è succube della noia, la stessa
che colpì Domenico Vannantò, uno dei personaggi di Vitaliano Brancati: Insomma
non gli restava che annoiarsi, annoiarsi nei modi più strani e diversi,
ma unicamente annoiarsi. E questo egli faceva, passando da una noia
avida e feroce, che divorasse quanto c’era all’intorno di odioso, a una
noia sorda e plumbea, in cui si spegnesse, come grido nella nebbia,
quanto c’era di vanitoso e petulante, a una noia lugubre e nera che
avvolgesse, nel pensiero castigatore della morte, quanto c’era di
stupidamente giulivo. Cu nesci, arrinesci: può darsi che a Roma o a Milano o
a Torino possa esserci la possibilità di sconfiggere l’angoscia della
noia ed il pessimismo per un futuro che esiste solo in qualità di
categoria temporale. In siciliano si dice che sappiamo che ci siamo svegliati stamattina, ma non sappiamo quello che ci capiterà prima che scuri. “Qui siamo e potremmo da un momento all’altro non esserci”. Alla Sicilia non interessa dei giovani che soffrono
per l’incapacità di godere d'una vita tranquilla; a Roma non aggrada
l’uguaglianza e ritiene che tutto possa risolversi col federalismo
fiscale, che piace tanto a Umberto Bossi e non si capisce perché piace anche a Raffaele Lombardo. Bisognerebbe andare da Silvio Berlusconi per dirgli: “Spettabile
Presidente, son qui per dimostrarle semplicemente ch’ esisto, in qualità
di giovane siciliano che è stanco di passare dal precariato alla
disoccupazione e dalla disoccupazione al precariato. Con tutta
sincerità: il problema si può risolvere oppure ci dobbiamo rassegnare
alla colpa di essere nati in Sicilia?”. Già: può darsi che
l’errore non stia in chi ha la facoltà di porre in essere una soluzione
alla questione della dignità del futuro del giovane meridionale, bensì
nei nostri genitori, nei nostri nonni, nei nostri antenati, che hanno
deciso di rimanere dove sono, anziché farci nascere altrove. Chissà
come sarebbe stata la vita, se fossimo nato a Vercelli, a Asti o a
Ivrea. “Ad ogni uccello il suo nido è bello”, scrisse Giovanni Verga.
Ne siamo sicuri? Ci sono ragazzi che si sono formati in
nuclei malavitosi e che hanno colmato la loro noia con l’illecito: la
crudele ed egoista mafia concepita come un datore di lavoro, come un
padre adottivo che ha a cuore il destino dei propri figli, strappati
allo Stato che non ha voluto curarsi di loro. Insomma, eredi di Salvatore Giuliano,
il bandito di Montelepre, che interpretò per alcuni anni
l’individuazione mitizzata dei sussulti di rivolta di ogni siciliano,
vittima dello Stato e della povertà. In realtà, era un delinquente, uno
che uccise a destra e a manca, uno spietato, seppur ingenuo. Ma sulla
Sicilia si nota spesso un denso e spinoso Velo di Maya ed i potenti non hanno alcun interesse a toglierlo, perché se le cose non cambiano, non è perché non possono cambiare, bensì perché non si vuole che cambino. Ecco il senso dell'immobilismo siciliano. Ma io, chi sugnu nuddu immiscatu cu nenti, non posso di certo aspettare che una nuova Santa Rosalia spunti
dal Monte Pellegrino e salvi la città dalla peste oche la madonna della lettera scenda dal piedistallo del porto per andare a Palazzo Zanca a prendere tutti a ceffoni. Quand’ero bambino non immaginavo
che non avrei avuto alcun punto fermo! Allora sognavo
che avrei avuto almeno la possibilità di coltivare il
futuro con un seme costante e proficuo! Ma l’intelligenza da sola non basta. In Sicilia se non hai le amicizie, se non hai i piccioli,
sei destinato ad essere ingoiato dal nulla. Di te non ha cura nessuno,
neanche Dio.
Chi va fuori, fa fortuna o, sicilianizzato, Cu nesci arrinesci. Lo scrive Gaetano Savatteri, nel libro I Siciliani, che “in
dialetto la frase assume ambiguo significato: da una parte, a voler
dire che in condizioni di vita meno soffocanti, in contesti più sereni,
il siciliano riesce a esprimere le proprie virtù e il proprio talento;
dall’altra, la frase è non solo l’alibi per i fallimenti o gli
insuccessi di chi ha preferito o ha dovuto rimanere in Sicilia, ma
nello stesso tempo la conferma che il senso di sé di ogni siciliano è
tale da non permettere a nessun altro di primeggiare”. Tutte occupazioni che non prevedono un fisso ma un
compenso a provvigioni sono in Sicilia. E si può andare avanti così? Certo che no, ma in sicilia non esiste qualcosa di duraturo, un lavoro che
possa permettere di guardare il futuro negli occhi. Ed in Sicilia ciò
non può accadere. Diceva Leonardo Sciascia: né con te né senza di te. Si sa che la vita è difficile per tutti, sia al Sud sia al
Nord, ma Milano non è Palermo; Torino non è Trapani; Verona non è
Agrigento; Bologna non è Messina. Potete dirmi che è difficile
dappertutto trovare lavoro, che la vita è più cara in Lombardia che in
Sicilia, però vi assicuro che nell’isola e nessuno fa
niente per migliorare la situazione, perché c’è a chi conviene.
Qui un giovane, senza amicizie di un certo peso, non ha alcuna
possibilità di farsi una famiglia ed è succube della noia, la stessa
che colpì Domenico Vannantò, uno dei personaggi di Vitaliano Brancati: Insomma
non gli restava che annoiarsi, annoiarsi nei modi più strani e diversi,
ma unicamente annoiarsi. E questo egli faceva, passando da una noia
avida e feroce, che divorasse quanto c’era all’intorno di odioso, a una
noia sorda e plumbea, in cui si spegnesse, come grido nella nebbia,
quanto c’era di vanitoso e petulante, a una noia lugubre e nera che
avvolgesse, nel pensiero castigatore della morte, quanto c’era di
stupidamente giulivo. Cu nesci, arrinesci: può darsi che a Roma o a Milano o
a Torino possa esserci la possibilità di sconfiggere l’angoscia della
noia ed il pessimismo per un futuro che esiste solo in qualità di
categoria temporale. In siciliano si dice che sappiamo che ci siamo svegliati stamattina, ma non sappiamo quello che ci capiterà prima che scuri. “Qui siamo e potremmo da un momento all’altro non esserci”. Alla Sicilia non interessa dei giovani che soffrono
per l’incapacità di godere d'una vita tranquilla; a Roma non aggrada
l’uguaglianza e ritiene che tutto possa risolversi col federalismo
fiscale, che piace tanto a Umberto Bossi e non si capisce perché piace anche a Raffaele Lombardo. Bisognerebbe andare da Silvio Berlusconi per dirgli: “Spettabile
Presidente, son qui per dimostrarle semplicemente ch’ esisto, in qualità
di giovane siciliano che è stanco di passare dal precariato alla
disoccupazione e dalla disoccupazione al precariato. Con tutta
sincerità: il problema si può risolvere oppure ci dobbiamo rassegnare
alla colpa di essere nati in Sicilia?”. Già: può darsi che
l’errore non stia in chi ha la facoltà di porre in essere una soluzione
alla questione della dignità del futuro del giovane meridionale, bensì
nei nostri genitori, nei nostri nonni, nei nostri antenati, che hanno
deciso di rimanere dove sono, anziché farci nascere altrove. Chissà
come sarebbe stata la vita, se fossimo nato a Vercelli, a Asti o a
Ivrea. “Ad ogni uccello il suo nido è bello”, scrisse Giovanni Verga.
Ne siamo sicuri? Ci sono ragazzi che si sono formati in
nuclei malavitosi e che hanno colmato la loro noia con l’illecito: la
crudele ed egoista mafia concepita come un datore di lavoro, come un
padre adottivo che ha a cuore il destino dei propri figli, strappati
allo Stato che non ha voluto curarsi di loro. Insomma, eredi di Salvatore Giuliano,
il bandito di Montelepre, che interpretò per alcuni anni
l’individuazione mitizzata dei sussulti di rivolta di ogni siciliano,
vittima dello Stato e della povertà. In realtà, era un delinquente, uno
che uccise a destra e a manca, uno spietato, seppur ingenuo. Ma sulla
Sicilia si nota spesso un denso e spinoso Velo di Maya ed i potenti non hanno alcun interesse a toglierlo, perché se le cose non cambiano, non è perché non possono cambiare, bensì perché non si vuole che cambino. Ecco il senso dell'immobilismo siciliano. Ma io, chi sugnu nuddu immiscatu cu nenti, non posso di certo aspettare che una nuova Santa Rosalia spunti
dal Monte Pellegrino e salvi la città dalla peste oche la madonna della lettera scenda dal piedistallo del porto per andare a Palazzo Zanca a prendere tutti a ceffoni. Quand’ero bambino non immaginavo
che non avrei avuto alcun punto fermo! Allora sognavo
che avrei avuto almeno la possibilità di coltivare il
futuro con un seme costante e proficuo! Ma l’intelligenza da sola non basta. In Sicilia se non hai le amicizie, se non hai i piccioli,
sei destinato ad essere ingoiato dal nulla. Di te non ha cura nessuno,
neanche Dio.
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
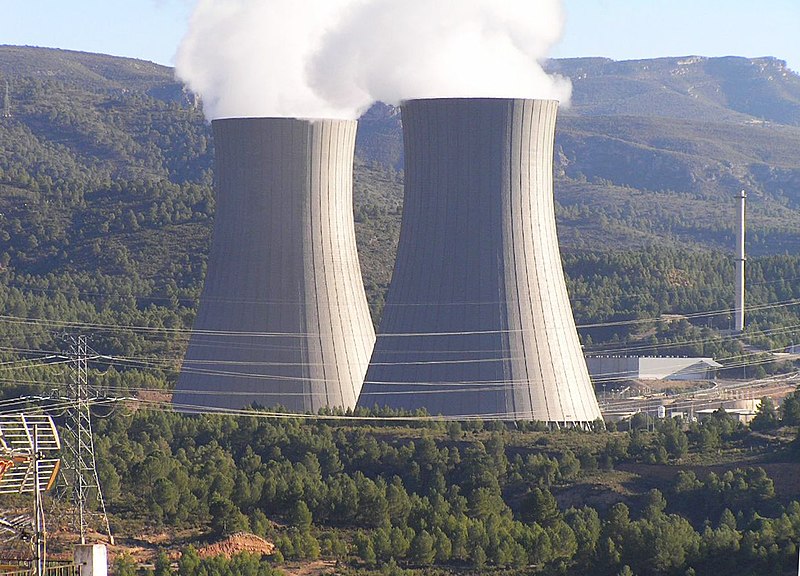 Per centrale nucleare si intende solitamente una centrale nucleare a fissione, ovvero una centrale elettrica che utilizza uno o più reattori nucleari a fissione per produrre energia.
Per centrale nucleare si intende solitamente una centrale nucleare a fissione, ovvero una centrale elettrica che utilizza uno o più reattori nucleari a fissione per produrre energia.
La fissione nucleare fu ottenuta sperimentalmente per la prima volta da Enrico Fermi nel 1934 bombardando l'uranio con neutroni. Nel 1938 i chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann, congiuntamente ai fisici austriaci Lise Meitner e Otto Robert Frisch, condussero esperimenti con i prodotti della reazione di bombardamento dell'uranio. Determinarono che il neutrone, relativamente piccolo, è in grado di scindere il nucleo dei pesanti atomi di uranio in due parti pressoché uguali. Numerosi scienziati (tra i primi Leo Szilard) compresero che le reazioni di fissione rilasciavano ulteriori neutroni, con il risultato di potere originare una reazione nucleare a catena in grado di alimentarsi da sola. Gli scienziati in molte nazioni (inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e l'URSS) furono spronati dai risultati sperimentali a chiedere ai loro rispettivi governi un supporto alla ricerca sulla fissione nucleare.
 Negli Stati Uniti, dove emigrarono sia Fermi che Szilard, fu costruito il primo reattore, conosciuto come Chicago Pile-1, che divenne critico il 2 dicembre 1942. Questo lavoro rientrò nell'ambito del progetto Manhattan, che portò anche alla costruzione di enormi reattori a Hanford allo scopo di produrre plutonio da utilizzare per le prime armi nucleari (parallelamente fu approntato un piano di arricchimento dell'uranio).
Negli Stati Uniti, dove emigrarono sia Fermi che Szilard, fu costruito il primo reattore, conosciuto come Chicago Pile-1, che divenne critico il 2 dicembre 1942. Questo lavoro rientrò nell'ambito del progetto Manhattan, che portò anche alla costruzione di enormi reattori a Hanford allo scopo di produrre plutonio da utilizzare per le prime armi nucleari (parallelamente fu approntato un piano di arricchimento dell'uranio).
Dopo la seconda guerra mondiale, il timore che la ricerca sui reattori potesse incoraggiare il rapido sviluppo di armi nucleari anche in funzione delle conoscenze accumulate, insieme all'opinione di molti scienziati che ritenevano occorresse un lungo periodo di sviluppo, crearono una situazione in cui la ricerca in questo settore fu tenuta sotto stretto controllo dai governi. Effettivamente, la maggioranza delle ricerche sui reattori era incentrata a fini puramente militari. L'elettricità venne prodotta per la prima volta da un reattore nucleare il 20 dicembre 1951, alla stazione sperimentale EBR-I (Experimental Breeder Reactor I) vicino ad Arco, che inizialmente produceva circa 100 kW (fu anche il primo reattore a subire un incidente di parziale fusione del nocciolo nel 1955). Nel 1953 un discorso del presidente Dwight Eisenhower, "Atomi per la pace", enfatizzò l'utilizzo dell'atomo per scopi civili e sostenne un piano politico per porre in primo piano gli Stati Uniti in un'ottica di sviluppo internazionale del nucleare. Nel 1954 Lewis Strauss, presidente della Atomic Energy Commission statunitense, in un convegno di scrittori scientifici sostenne: "Non è troppo aspettarsi che i nostri figli usufruiranno nelle loro case di energia elettrica troppo economica per poter essere misurata".
 Il 27 giugno 1954, la centrale nucleare di Obninsk divenne il primo impianto al mondo a generare elettricità per una rete di trasmissione e produceva circa 5 MW di potenza.
Il 27 giugno 1954, la centrale nucleare di Obninsk divenne il primo impianto al mondo a generare elettricità per una rete di trasmissione e produceva circa 5 MW di potenza.
Nel 1955 la "Prima Conferenza di Ginevra" delle Nazioni Unite, il più grande incontro mondiale di scienzati e ingegneri, si riunì per studiare la tecnologia. Nel 1957 venne lanciata l'EURATOM accanto alla Comunità Economica Europea (quella che successivamente divenne l'Unione Europea). Nello stesso anno nacque anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA).
La prima centrale nucleare commerciale al mondo fu quella di Calder Hall, a Sellafield in Inghilterra, e iniziò a lavorare nel 1956 con una potenza iniziale di 50 MW (successivamente divenuti 200 MW). Il primo reattore nucleare operativo negli Stati Uniti fu invece il reattore di Shippingport, in Pennsylvania (dicembre 1957).
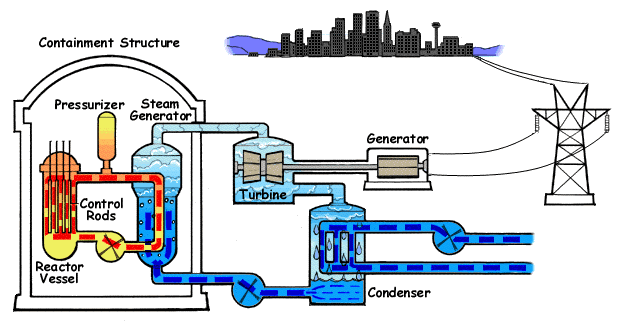 La potenza complessiva delle centrali nucleari aumentò velocemente, passando da meno di 1 GW
nel 1960 a 100 GW nei tardi anni settanta e 300 GW nei tardi anni
ottanta. Dal tardo 1980 la potenza è andata crescendo molto più
lentamente, raggiungendo i 366 GW nel 2005, con la maggiore espansione
avutasi in Cina.
Tra il 1970 e il 1990 furono in costruzione centrali per più di 50 GW
di potenza, con un picco a oltre 150 GW tra il tardo 1970 e i primi
anni ottanta; nel 2005 sono stati pianificati circa 25 GW di nuova
potenza. Più dei 2/3 di tutti gli impianti nucleari programmati dopo il
gennaio 1970 furono alla fine cancellati.
La potenza complessiva delle centrali nucleari aumentò velocemente, passando da meno di 1 GW
nel 1960 a 100 GW nei tardi anni settanta e 300 GW nei tardi anni
ottanta. Dal tardo 1980 la potenza è andata crescendo molto più
lentamente, raggiungendo i 366 GW nel 2005, con la maggiore espansione
avutasi in Cina.
Tra il 1970 e il 1990 furono in costruzione centrali per più di 50 GW
di potenza, con un picco a oltre 150 GW tra il tardo 1970 e i primi
anni ottanta; nel 2005 sono stati pianificati circa 25 GW di nuova
potenza. Più dei 2/3 di tutti gli impianti nucleari programmati dopo il
gennaio 1970 furono alla fine cancellati.
Durante gli anni settanta e ottanta il crescere dei costi economici (legati ai tempi di costruzione delle centrali) e la diminuzione dei prezzi dei combustibili fossili resero gli impianti nucleari allora in costruzione meno attrattivi. Negli anni ottanta, negli Stati Uniti, e negli anni novanta, in Europa, la crescita meno marcata della potenza e la liberalizzazione dell'elettricità hanno anche contribuito a rendere la tecnologia meno attraente.
La crisi del petrolio del 1973 ebbe un forte effetto sulle politiche energetiche: la Francia e il Giappone che usavano sopratutto petrolio per produrre energia elettrica (rispettivamente, in tal modo producevano il 39% e il 73% dell'energia elettrica totale) investirono sul nucleare. Oggi le centrali nucleari forniscono rispettivamente circa l'80% e il 30% di elettricità in queste nazioni.
 Molte nazioni restano particolarmente attive nello sviluppo dell'energia nucleare, tra le quali Giappone, Cina, India, tutte attive nello sviluppo della tecnologie sia veloce sia termica; la Sud Corea e gli Stati Uniti solamente nello sviluppo della tecnologia termica; e Sud Africa e Cina nello sviluppo di versioni di reattore nucleare modulare pebble bed (PBMR). Finlandia e Francia perseguono attivamente programmi nucleari; la Finlandia ha in costruzione uno dei primi reattori nucleari di III generazione del tipo EPRAreva, che attualmente è in ritardo di due anni rispetto ai programmi.
Il Giappone ha un attivo programma di costruzione di centrali nucleari
con nuove unità divenute operative nel 2005. Negli Stati Uniti tre
consorzi risposero nel 2004 alla sollecitazione dello United States Department of Energy
riguardante il "Programma di Energia Nucleare 2010" e furono compensati
con fondi per la costruzione di nuovi reattori, tra cui un reattore di
quarta generazione VHTR concepito per produrre sia elettricità che idrogeno. Nei primi anni del ventunesimo secolo
l'energia nucleare ha destato particolare interesse in Cina e India per
sostenere il loro rapido sviluppo economico; entrambe stanno
sviluppando reattori riproduttori rapidi.
La politica energetica del Regno Unito riconosce la probabile futura
carenza di approvvigionamento energetico, che potrà essere colmata
dalla costruzione di nuove centrali nucleari o prolungando il tempo di
vita degli attuali impianti esistenti.
Molte nazioni restano particolarmente attive nello sviluppo dell'energia nucleare, tra le quali Giappone, Cina, India, tutte attive nello sviluppo della tecnologie sia veloce sia termica; la Sud Corea e gli Stati Uniti solamente nello sviluppo della tecnologia termica; e Sud Africa e Cina nello sviluppo di versioni di reattore nucleare modulare pebble bed (PBMR). Finlandia e Francia perseguono attivamente programmi nucleari; la Finlandia ha in costruzione uno dei primi reattori nucleari di III generazione del tipo EPRAreva, che attualmente è in ritardo di due anni rispetto ai programmi.
Il Giappone ha un attivo programma di costruzione di centrali nucleari
con nuove unità divenute operative nel 2005. Negli Stati Uniti tre
consorzi risposero nel 2004 alla sollecitazione dello United States Department of Energy
riguardante il "Programma di Energia Nucleare 2010" e furono compensati
con fondi per la costruzione di nuovi reattori, tra cui un reattore di
quarta generazione VHTR concepito per produrre sia elettricità che idrogeno. Nei primi anni del ventunesimo secolo
l'energia nucleare ha destato particolare interesse in Cina e India per
sostenere il loro rapido sviluppo economico; entrambe stanno
sviluppando reattori riproduttori rapidi.
La politica energetica del Regno Unito riconosce la probabile futura
carenza di approvvigionamento energetico, che potrà essere colmata
dalla costruzione di nuove centrali nucleari o prolungando il tempo di
vita degli attuali impianti esistenti.
Il 20 dicembre 2002 il Consiglio dei Ministri bulgaro si espresse favorevolmente alla ripresa della costruzione della centrale nucleare di Belene. Le fondamenta dell'impianto furono poste nel 1987, però la costruzione fu abbandonata nel 1990, con il primo reattore pronto al 40%. Si prevede che il primo reattore divenga operativo nel 2013, e il secondo nel 2014.
 Le centrali nucleari a fissione seguono oggi standard di sicurezza di
livello molto elevato e normalmente condensano al loro interno un
bagaglio tecnologico molto avanzato per la gestione di tutti i
processi. Le centrali nucleari a fissione sono di fatto tra gli
impianti più controllati in uso oggi anche se storicamente si sono
verificati diversi incidenti
di gravità più o meno seria che hanno permesso di affinare procedure e
tecniche costruttive inerenti la prevenzione. Prendendo in esame il
problema dal punto di vista puramente tecnico, una centrale nucleare
recente integra sistemi di protezione (ad esempio di caduta del
nocciolo) e di verifica tali da mitigare (ma non annullare) tutti i
problemi prevedibili.
Le centrali nucleari a fissione seguono oggi standard di sicurezza di
livello molto elevato e normalmente condensano al loro interno un
bagaglio tecnologico molto avanzato per la gestione di tutti i
processi. Le centrali nucleari a fissione sono di fatto tra gli
impianti più controllati in uso oggi anche se storicamente si sono
verificati diversi incidenti
di gravità più o meno seria che hanno permesso di affinare procedure e
tecniche costruttive inerenti la prevenzione. Prendendo in esame il
problema dal punto di vista puramente tecnico, una centrale nucleare
recente integra sistemi di protezione (ad esempio di caduta del
nocciolo) e di verifica tali da mitigare (ma non annullare) tutti i
problemi prevedibili.
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Nella crisi del Caucaso ci sono già tutti gli elementi della prossima guerra mondiale, che sarà nucleare solo un pochino e che forse sarà evitata grazie a Cina e India. E' questa l'analisi di Nikolai Sokolov, esperto di geopolitica nel mondo post-sovietico.
Nella crisi del Caucaso ci sono già tutti gli elementi della prossima guerra mondiale, che sarà nucleare solo un pochino e che forse sarà evitata grazie a Cina e India. E' questa l'analisi di Nikolai Sokolov, esperto di geopolitica nel mondo post-sovietico.
Secondo lo studioso, la posta in palio in Georgia è poco più che simbolica, ma Russia e Usa non possono mollare l'osso per diversi motivi: promesse e alleanze con player locali, reputazione e ruolo nel contesto globale.
La situazione assomiglia molto a quella europea alla vigilia della prima guerra mondiale, quando l'assassinio dell'arciduca austriaco Francesco Ferdinando scatenò una reazione a catena inevitabile.
Come potrebbe scoppiare il conflitto? Semplice: la Georgia starebbe per entrare nella Nato. Ma se negli Stati Uniti questa ipotesi è molto popolare - perché entrambi i candidati alle presidenziali giocano la carta georgiana per acquisire consensi - altri membri dell'Alleanza (definiti "vecchia Europa" da Rumsfeld) non ne sono così entusiasti. Inoltre si tratta di un processo lungo.
A questo punto, il presidente georgiano Saakashvili potrebbe semplicemente stringere un'alleanza bilaterale con gli Usa, facendo dispiegare sul suo territorio due o tre battaglioni di soldati americani. Di fatto, se Tbilisi decidesse di soffiare sul fuoco, si tratterebbe di "ostaggi" in un gioco più grande di loro. Un'ulteriore provocazione di Saakashvili nei confronti della Russia, come quella di agosto, non potrebbe che scatenare la stessa reazione di Mosca.
Ma a quel punto gli americani, implicati direttamente, non potrebbero
starsene a guardare e, tra l'altro, non avrebbero i lacci e lacciuoli
dell'Alleanza Atlantica a limitarne la libertà d'azione.
 La Russia schiaccerebbe la Georgia ma non avrebbe chances contro la superiorità tecnologica statunitense. Dovrebbe perciò ricorrere a un limitato uso della sua forza nucleare contro i centri di comando e le basi Usa, soprattutto in Europa, da cui partono gli attacchi contro il proprio territorio.
La Russia schiaccerebbe la Georgia ma non avrebbe chances contro la superiorità tecnologica statunitense. Dovrebbe perciò ricorrere a un limitato uso della sua forza nucleare contro i centri di comando e le basi Usa, soprattutto in Europa, da cui partono gli attacchi contro il proprio territorio.
"Benvenuti alla terza guerra mondiale - scherza Sokolov - in gran parte convenzionale e resa qua e là più piccante da qualche fungo nucleare".
Ma l'aspetto più affascinante - aggiunge - è il fatto che le due potenze emergenti sullo scacchiere globale, Cina e India, sarebbero totalmente disinteressate all'intera faccenda, non avendo mire particolari sul Caucaso.
"Se superiamo in sicurezza questo periodo di transizione - in cui il potere economico e quindi politico si sta trasferendo dai vecchi centri all'Asia
- potremmo evitare un scontro diretto tra grandi potenze e l'uso di
armi nucleari. In base alle attuali tendenze economiche, necessitiamo
di un po' di fortuna ancora per qualche anno, bisogna sperare nell'ascesa di Cina e India per evitarla.
Altri articoli …
- Gli animali più strani del mondo
- La Mosca dell' Olivo
- Nel tabacco è presente il polonio. Elemento Radioattivo
- Le discariche. Cosa dovrebbero essere
- Meno rifiuti produrrai e più vivrai
- Rispetta l'Ambiente in 20 mosse
- Il passaggio al mare un diritto del cittadino
- L'Acqua : il petrolio dei poveri
- Siamo nell'era della Globesità
- Usain Bolt li fa in 19,30
Pagina 70 di 76









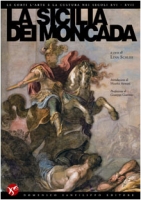

 Home Page
Home Page