Curiosità dal Web - LarderiaWeb
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Rispettare la natura, riciclare i rifiuti, conoscere le alternative possibili sono diventate una necessità per tutti gli abitanti del globo. Ma con semplici mosse come quelle elencate possiamo aiutare noi stessi ed i nostri figli a rispettare ciò che ci circonda. Dare una mano all'ambiente è facile.... a voi 20 mosse intelligenti. Usatele!!!!
Rispettare la natura, riciclare i rifiuti, conoscere le alternative possibili sono diventate una necessità per tutti gli abitanti del globo. Ma con semplici mosse come quelle elencate possiamo aiutare noi stessi ed i nostri figli a rispettare ciò che ci circonda. Dare una mano all'ambiente è facile.... a voi 20 mosse intelligenti. Usatele!!!!
2. Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa consumare petrolio e aumentare l'effetto serra.
3. Abbassa la temperatura: vivi meglio ed inquini di meno
4. Usa meglio gli elettrodomestici: spegni pc e televisore, lo "stand-by" consuma, quindi inquina
5. Prendi il sole. Come? Con i pannelli solari.
6. Cambia (appena puoi) la macchina: e sceglila a metano o gpl. E, soprattutto, usala il meno possibile
7. Tieni i piedi per terra: gli aerei provocano il 10% dell'effetto serra mondiale
8. Mangia frutta e verdura (se biologiche, meglio): fa sorridere, ma ovini e bovini sono responsabili del 18% delle emissioni mondiali di gas serra, oltre a favorire per il loro sfruttamento intensivo la deforestazione
9. Usa pannolini eco-compatibili: la biodegradazione di quelli "tradizionali" richiede 500 anni
10. Per conservare i cibi, usa vetro e non alluminio: inquina, e per la sua produzione lo spreco energetico è enorme
11. Informati con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e tv che ti parlano di ambiente e sviluppo sostenibile
12. Non incartarti: utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere documenti e per informarti: salvi alberi e non inquini coi trasporti
13. Pulisciti i denti, ma con intelligenza: se la lasci scorrere, getti fino a 30 litri d'acqua. Aprila solo quando li risciacqui
14. Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di meno e durano 10 volte di più.
15. Mangia sano, scegli il biologico: è un metodo di coltivazione rispettoso dell'ambiente
16. Mangia consapevole: sono buoni, ma per la produzione di hamburger si stanno distruggendo intere foreste. Pensaci.
17. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti consumi 40 litri d'acqua, in 10 minuti più di 130 litri.
18. Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto: fallo durare il più a lungo possibile
19. Usa e getta? No grazie. Per esempio, usa pile ricaricabili: si possono ricaricare fino a 500 volte.
20. Fai la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che puoi dare all'ambiente
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 Amate il mare ma non gli stabilimenti balneari e provate una sgradevole sensazione da villetta a schiera alla vista delle venti file di sdraio che vi separano dal bagnasciuga. Oppure avete semplicemente l'occasione di fare un tuffo domenicale ma non volete pagare un ombrellone come un monolocale. Insomma vorreste solo raggiungere l'acqua gratuitamente e senza gimkane. Vorreste, appunto.
Amate il mare ma non gli stabilimenti balneari e provate una sgradevole sensazione da villetta a schiera alla vista delle venti file di sdraio che vi separano dal bagnasciuga. Oppure avete semplicemente l'occasione di fare un tuffo domenicale ma non volete pagare un ombrellone come un monolocale. Insomma vorreste solo raggiungere l'acqua gratuitamente e senza gimkane. Vorreste, appunto.
Ma ogni bagnante-fai-da-te sa quanto è difficile, in molti tratti della costa italiana, trovare una spiaggia libera. O rivendicare il diritto di arrivare al mare senza pagare anche se c'è di mezzo il lido privato. Perché fare il bagno senza sentirsi uno squatter non è una pretesa ma un diritto sancito dalla legge. Che troppo spesso viene dimenticato dai concessionari degli stabilimenti.
Una legge scritta sulla sabbia
E' per questo che l'organismo di difesa dei consumatori Adiconsum rilancia sul sito la campagna per le spiagge libere. "Andare in uno stabilimento deve essere una scelta, non un obbligo imposto dalla mancanza di spiagge libere", sostiene Paolo Landi, segretario generale dell'associazione. Il problema è duplice:
-
la mancanza di un "un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili direttamente fruibili",
-
il mancato rispetto dell'"obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione".
Sono due principi stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 251 e 254 ) che in troppi casi sono rimasti lettera morta. Per prima cosa è sotto gli occhi di tutti che in molti tratti di costa il "corretto equilibrio" tra spiaggia libera e "privata" non esiste. Ma si potrebbe tollerare meglio l'occupazione dei litorali se venisse rispettato l'altro principio, il libero e gratuito accesso al mare.
I diritti del bagnante-fai-da-te
 Ecco, in concreto, quali sono i diritti che ogni libero bagnante può far valere in caso di controversie con i gestori degli stabilimenti (anche rivolgendosi alla Polizia municipale o alla Capitaneria di porto):
Ecco, in concreto, quali sono i diritti che ogni libero bagnante può far valere in caso di controversie con i gestori degli stabilimenti (anche rivolgendosi alla Polizia municipale o alla Capitaneria di porto):
• La battigia - intesa coma una striscia di sabbia di 5 metri che parte dal punto in cui arriva l'onda - è esclusa dalla concessione, quindi è a disposizione di tutti.
• Sulla battigia tutti possono camminare, sedersi e sdraiarsi. Dev'essere garantito il passaggio
e quindi nessuno (nemmeno lo stabilimento) può occuparla con oggetti
ingombranti come ombrelloni, lettini ecc. E' possibile invece
appoggiare gli abiti o l'asciugamano mentre si fa il bagno.
• L'accesso al mare dev'essere sempre garantito e gratuito. Pertanto non può essere impedito il transito attraverso l'area in concessione per raggiungere la battigia né può essere richiesto un pagamento.
Un business allettante
Una curiosità: il canone che ogni stabilimento paga allo Stato per la concessione dell'area è fissato dalla legge. Se la spiaggia è considerata di categoria A ("ad alta valenza turistica") e ha delle strutture fisse (ad esempio le cabine) si arriva ai 4,13 euro/mq all'anno. Ma la stragrande maggioranza delle spiagge è classificata in categoria B e si arriva a un massimo di 2,65 euro/mq. Uno stabilimento di 5.000 mq costa dunque poco più di 13.000 euro all'anno. Considerando che il prezzo di una cabina + ombrellone + sdraio per una stagione oscilla tra i 1.000 ai 3.000 euro, non è difficile capire che si tratta di un buon affare per i gestori.
L'accesso al bagnasciuga è un diritto. Lo stabilimento balneare non può impedire il passaggio né farlo pagare.
{mosgoogle center}
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 L’acqua sulla Terra è il 40 per cento in meno di trent’anni fa, e nel 2020 tre miliardi di persone resteranno senza. Ma gli Stati più forti stanno già sfruttando la situazione per trasformare questa risorsa in bene commerciabile.
L’acqua sulla Terra è il 40 per cento in meno di trent’anni fa, e nel 2020 tre miliardi di persone resteranno senza. Ma gli Stati più forti stanno già sfruttando la situazione per trasformare questa risorsa in bene commerciabile.
Il pianeta è rimasto a secco e, guarda caso, ce ne siamo accorti troppo
tardi. Sotto la spinta della crescita demografica e per effetto
dell’inquinamento, le risorse idriche pro capite negli ultimi
trent’anni si sono ridotte del 40 per cento. Gli scienziati avvertono
che, intorno al 2020, quando ad abitare la terra saremo circa 8 miliardi, il numero delle persone senza accesso all’acqua potabile sarà di 3 miliardi circa.
Le soluzioni prospettate finora per far fronte al problema hanno cercato di aumentare l’offerta, piuttosto che di contenere la domanda, rivelandosi però inefficaci: le grandi dighe sono al centro di dibattiti per gli alti costi umani e ambientali e per la razionalità ecologica, mentre la desalinizzazione, oltre ad avere costi economici proibitivi, presenta forti controindicazioni dal punto di vista ambientale ed energetico. Questi e altri stratagemmi mostrano tutti i loro limiti rispetto al complesso ecosistema del ciclo dell’acqua.
 Di fronte al fallimento della tecnica, aumentano le previsioni
catastrofiche sulla battaglia planetaria che si scatenerà per l’accesso
all’”oro blu” del XXI secolo. Di fronte ai dati
allarmanti sullo stato delle risorse idriche del pianeta, la maggior
parte degli esperti hanno dichiarato che “le guerre del ventunesimo
secolo scoppieranno a causa delle dispute sull’accesso all’acqua”.
Di fronte al fallimento della tecnica, aumentano le previsioni
catastrofiche sulla battaglia planetaria che si scatenerà per l’accesso
all’”oro blu” del XXI secolo. Di fronte ai dati
allarmanti sullo stato delle risorse idriche del pianeta, la maggior
parte degli esperti hanno dichiarato che “le guerre del ventunesimo
secolo scoppieranno a causa delle dispute sull’accesso all’acqua”.
Quello delle “guerre per l’acqua”
è un tema che si presta a catturare l’attenzione e le preoccupazioni
dell’opinione pubblica, vista la centralità - e addirittura la
sacralità - che l’acqua riveste in molte società e culture. Eppure il
discorso, presentato esclusivamente nei termini della crescente
scarsità - e conseguente rischio di conflitti armati - può risultare
semplicistico: si tende a presentare la situazione come immodificabile,
quasi apocalittica, senza interrogarsi sulle cause reali che hanno
portato il pianeta sull’orlo del collasso idrico e che impediscono a un
terzo dell’umanità di avere l’accesso diretto alle acque potabili.
 Viene da chiedersi come mai la Cina, sul cui territorio si concentrano più del 40 per cento delle risorse idriche mondiali,
si trova ad affrontare una grave penuria d’acqua potabile e irrigua:
mettendo al primo posto la crescita industriale, il governo di Pechino
non si è infatti preoccupato di tutelare le risorse ambientali, e
attualmente un terzo dei corsi d’acqua è inquinato, mentre nelle città il 50 per cento dell’acqua non è potabile.
E le vendite dell’acqua in bottiglia delle multinazionali esplodono
grazie alla preoccupazione dei consumatori per la scarsa qualità
dell’acqua del rubinetto.
Viene da chiedersi come mai la Cina, sul cui territorio si concentrano più del 40 per cento delle risorse idriche mondiali,
si trova ad affrontare una grave penuria d’acqua potabile e irrigua:
mettendo al primo posto la crescita industriale, il governo di Pechino
non si è infatti preoccupato di tutelare le risorse ambientali, e
attualmente un terzo dei corsi d’acqua è inquinato, mentre nelle città il 50 per cento dell’acqua non è potabile.
E le vendite dell’acqua in bottiglia delle multinazionali esplodono
grazie alla preoccupazione dei consumatori per la scarsa qualità
dell’acqua del rubinetto.
I conflitti per l’accesso all’acqua iniziano all’interno dello Stato, coinvolgendo e opponendo i grossi coltivatori - fautori dell’agricoltura intensiva - ai piccoli proprietari terrieri, gli industriali agli operatori turistici, ma soprattutto tagliando fuori le comunità rurali e indigene il cui “approccio” all’acqua è, per così dire, di tipo imprenditoriale, e, inevitabilmente, gli abitanti delle periferie delle megalopoli, in cui le infrastrutture igienico-sanitarie sono poche o nulle. Questo tipo di conflitti non dipende tanto da fattori naturali come il clima o la dotazione di risorse idriche, quanto dalle scelte politiche, economiche e sociali.
In Bolivia, dove l’acqua non manca, si è proclamato
lo stato d’assedio per frenare le azioni di protesta diffuse in tutto
il paese contro l’aumento delle tariffe dell’acqua previsto dal
progetto governativo della Legge delle Acque che ne affida la gestione
a un consorzio di multinazionali europee e americane.
 Attualmente, nel mondo ci sono circa cinquanta conflitti tra
Stati per cause legate all’accesso, all’utilizzo e alla proprietà di
risorse idriche. Anche in questo caso, la maggior parte delle analisi
citano come causa primaria un divario sempre più ampio tra la domanda e
l’offerta, e, senza dubbio, si tratta di fattori cruciali: la zona in
cui lo “stress idrico” minaccia da un momento all’altro di trasformarsi
in conflitto armato è quella del Medio Oriente, dove il clima e le
riserve idriche sono tra i più disgraziati del pianeta. Ma le
spiegazioni basate sulla penuria d’acqua sono solo una mezza verità:
che dire ad esempio della Turchia, vero e proprio chateau d’eau del
Medio Oriente, con risorse idriche pro capite superiori a quelle
italiane, e che però combatte da anni con Siria e Iraq per il controllo
di Tigri ed Eufrate?
Attualmente, nel mondo ci sono circa cinquanta conflitti tra
Stati per cause legate all’accesso, all’utilizzo e alla proprietà di
risorse idriche. Anche in questo caso, la maggior parte delle analisi
citano come causa primaria un divario sempre più ampio tra la domanda e
l’offerta, e, senza dubbio, si tratta di fattori cruciali: la zona in
cui lo “stress idrico” minaccia da un momento all’altro di trasformarsi
in conflitto armato è quella del Medio Oriente, dove il clima e le
riserve idriche sono tra i più disgraziati del pianeta. Ma le
spiegazioni basate sulla penuria d’acqua sono solo una mezza verità:
che dire ad esempio della Turchia, vero e proprio chateau d’eau del
Medio Oriente, con risorse idriche pro capite superiori a quelle
italiane, e che però combatte da anni con Siria e Iraq per il controllo
di Tigri ed Eufrate?
Quello turco - ma anche quello dell’Egitto nei confronti di Etiopia e Sudan, e di Israele verso i suoi vicini arabi, tanto per citarne qualcuno - è un classico esempio di “idropolitica”, ovvero di politica fatta con l’acqua: strumento strategico per assicurarsi il potere e la supremazia economica in una determinata regione.
Nelle zone più aride la questione idrica è sempre servita ad alimentare la propaganda di regimi nazionalisti, così l’acqua si è trasformata, di volta in volta, in obiettivo strategico da colpire per indebolire l’avversario, in uno strumento di ricatto che serviva a garantire la supremazia regionale. Con l’attuazione del progetto Gap, che prevede la realizzazione di 22 dighe e 19 centrali idroelettriche, la Turchia ha due obiettivi: ribadire la sua supremazia rispetto a Siria e Iraq - anche quelli alle prese con progetti idraulici altrettanto imponenti - e controllare militarmente (con la scusa di proteggere i cantieri dagli attentati) i territori dell’Anatolia sudorientale, che da sempre sono roccaforte dei curdi.
 Il caso turco, così come quello israeliano, dimostra come le “guerre
per l’acqua” possano essere la conseguenza più che la causa delle
tensioni internazionali, e rivela la pericolosità delle logiche
dell’idropolitica. Una politica di potenza basata sul ricatto idrico, e
sulle difficoltà di approvvigionamento degli avversari, non è certo la
strada migliore per risolvere la penuria d’acqua: al contrario, tende a
“mantenere” la scarsità per poter far valere i propri meccanismi. E’
chiaro che, in questo contesto, la proposta di considerare l’acqua come
bene economico raro, assegnandole un prezzo di mercato che ne rifletta
la scarsità, non favorisce la pace e la cooperazione, come sostengono i
suoi fautori, ma porta dritti alla petrolizzazione dell’acqua. La
soluzione ai problemi legati alla scarsità idrica in molti casi non si
trova nell’acqua, o in costose e discutibili soluzioni tecniche, ma
passa per la volontà politica dei dirigenti. Che vuol dire avviare una
seria cooperazione a livello regionale e internazionale, niente di
nuovo insomma, cambia il motivo del contendere ma non i risultati.
Il caso turco, così come quello israeliano, dimostra come le “guerre
per l’acqua” possano essere la conseguenza più che la causa delle
tensioni internazionali, e rivela la pericolosità delle logiche
dell’idropolitica. Una politica di potenza basata sul ricatto idrico, e
sulle difficoltà di approvvigionamento degli avversari, non è certo la
strada migliore per risolvere la penuria d’acqua: al contrario, tende a
“mantenere” la scarsità per poter far valere i propri meccanismi. E’
chiaro che, in questo contesto, la proposta di considerare l’acqua come
bene economico raro, assegnandole un prezzo di mercato che ne rifletta
la scarsità, non favorisce la pace e la cooperazione, come sostengono i
suoi fautori, ma porta dritti alla petrolizzazione dell’acqua. La
soluzione ai problemi legati alla scarsità idrica in molti casi non si
trova nell’acqua, o in costose e discutibili soluzioni tecniche, ma
passa per la volontà politica dei dirigenti. Che vuol dire avviare una
seria cooperazione a livello regionale e internazionale, niente di
nuovo insomma, cambia il motivo del contendere ma non i risultati.
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web
 E’ in corso da diversi mesi in Italia una serie di iniziative atte a
riportare in auge l’attualità e l’urgenza del dibattito sulle strette
relazioni che intercorrono tra abitudini alimentari,
buone pratiche di cottura e benefici nutrizionali, considerato anche
l’ultimo Rapporto sulla Salute nel Mondo pubblicato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
E’ in corso da diversi mesi in Italia una serie di iniziative atte a
riportare in auge l’attualità e l’urgenza del dibattito sulle strette
relazioni che intercorrono tra abitudini alimentari,
buone pratiche di cottura e benefici nutrizionali, considerato anche
l’ultimo Rapporto sulla Salute nel Mondo pubblicato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Ingredienti, quelli appena citati, che possono concretamente incidere sul benessere fisico e psicofisico dei consumatori.
L’evento “La Nutrizione non è solo questione di ingredienti”,
ha ospitato l’autorevole intervento del professor Michele Carruba,
Direttore del Centro Studi e Ricerca sull’Obesità, Università degli
Studi di Milano.
In primis, forte degli ultimi dati aggiornati, il Professore ha
analizzato la situazione italiana relativamente ai problemi del
sovrappeso ed obesità, per poi auspicare soluzioni concrete, pienamente
compatibili con la nostra pratica quotidiana, a favore di
un’alimentazione equilibrata e salutare.
I risultati delle indagini specifiche sono preoccupanti, tanto da indurre l’OMS a parlare di “Globesità”, temine assai efficace che ben rappresenta uno scenario generalizzato caratterizzato dalla crescita epidemica di sovrappeso ed obesità che coinvolge oggi parecchie aree del mondo.
 Se infatti da una parte il Rapporto sulla Salute nel Mondo dell’OMS certifica che oltre un miliardo di persone è sovrappeso (di cui 300 milioni obeso), dall’altra il dato italiano non smentisce affatto questa tendenza.
Se infatti da una parte il Rapporto sulla Salute nel Mondo dell’OMS certifica che oltre un miliardo di persone è sovrappeso (di cui 300 milioni obeso), dall’altra il dato italiano non smentisce affatto questa tendenza.
Anzi, nel nostro paese la situazione assume toni addirittura critici: 1 italiano su 10 è obeso e 4 su 10 sono sovrappeso.
Investigando le cause emerge che non si tratta soltanto di fattori genetici e costituzionali: le ragioni sono molteplici e riconducibili soprattutto ad abitudini alimentari disordinate e poco controllate, dove domina lo scarso consumo di frutta e verdura, la propensione al fast-food fuori casa, il poco tempo dedicato a cucinare, l’abuso di alimenti surgelati o precotti e l’insufficiente attenzione ai valori nutrizionali.
Il Prof. Carruba ha sottolineato il legame esistente tra
un’alimentazione corretta ed equilibrata ed i metodi di cottura
utilizzati, ed ha suggerito accorgimenti che possono essere facilmente
adottati nella quotidianità.
Si tratta di soluzioni altamente praticabili: dall’equilibrata
ripartizione del fabbisogno nutrizionale tra i diversi pasti della
giornata, all’attenzione nei confronti degli ingredienti selezionati,
fino al controllo delle modalità con cui tali pietanze vengono cucinate.
La metodologia di cottura, oltre ad incidere sul gusto, esercita
un’influenza fondamentale sulla salute per le importanti ricadute sul
valore nutrizionale dell’alimento.
{mosgoogle center}
- Dettagli
- Categoria: Curiosità dal Web

Scheda Usain Bolt
Nascita 21 agosto 1986 a Trelawny
Nazionalità Giamaica
Altezza 1.96
Peso 86 kg
Palmarès Usain Bolt
Mondiali
Argento Osaka 2007 200m
Argento Osaka 2007 4×100m
Olimpiadi
Oro Pechino 2008 100m WR :
Oro Pechino 2008 200m WR : 19,30
{mosgoogle center}
Altri articoli …
- La Birra: un piacere di 13000 anni fa
- Le droghe fanno male !!!
- La canapa indiana come cura medica
- Il drago sotto spirito
- Gli UFO esistono. Lo dice anche la Bibbia
- Ritrovato il cadavere di una sirena
- Come creare elettricità
- Consigli per risparmiare e non inquinare
- Bombolette spray , un pericolo per la tua casa
- Recicla per lasciare un mondo migliore ai tuoi figli
Pagina 72 di 76









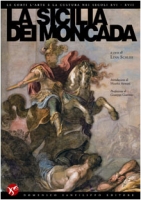

 Home Page
Home Page