- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
Lungo la strada Provinciale 39 per Larderia, a circa due chilomentri da Larderia Superiore vi è un altro insediamento abitativo; il villaggio di Tipoldo. Appollaiato su di un ripido costone che guarda verso la vallata di Mili S.Pietro a circa 430 m s.l. il piccolo villaggio ha la caratteristica di essere circondato da vigneti e da qualsiasi parte si volge lo sguardo si vede il bellissimo panorama dello stretto. Tipoldo non ha mai avuto una delegazione in quanto facente parte nei decenni passati di quella di Mili S.Pietro per questo non abbiamo molte notizie sulla storia demografica e culturale di questo piccolo e simpatico centro della vallata di Larderia. La stessa Parrocchia è stata istituita nel 1943 e la nuova chiesa è stata consegnata hai fedeli solo negli anni '70. Probabilmente Tipoldo venne considerato come villaggio solo verso la fine del 1800 quando venne inserito nel progetto dell' Acquedotto civico di Messina.
Di non datata origine, a tipoldo, ancora si può ammirare l'imponente Chiesa di S.Giuseppe, ormai dismessa. Rimane solo la parte esterna, senza tetto.
Oggi Tipoldo è un paese tranquillo dove gli abitanti vivono la loro vita con la spensieratezza che forse in molti abbiamo perso. Caratteristico del paese di Tipoldo, il pane, impastato a mano e cotto in piccoli forni a carattere familiare. Non è raro nel piccolo paese sentire tra i vicoli quell'odore di..... abbrustolito, che è solo di paesi come Tipoldo.

- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
 Un panoramicissimo paese Larderia Superiore, posizionato su un ripido poggio della vallata. Si trova a destra del torrente di Larderia a quota 220 m s.l. a poca distanza dal paese inferiore. Un susseguirsi di vicoli e scalinate che sboccano tutte nella piazza antistante l'antica chiesa di S.Sebastiano, intitolata ad un tempo a S.Anna.
Un panoramicissimo paese Larderia Superiore, posizionato su un ripido poggio della vallata. Si trova a destra del torrente di Larderia a quota 220 m s.l. a poca distanza dal paese inferiore. Un susseguirsi di vicoli e scalinate che sboccano tutte nella piazza antistante l'antica chiesa di S.Sebastiano, intitolata ad un tempo a S.Anna.
Il Campanile è del '700 a cupolino e con decorazioni tipicamente rococò. I due paesi, Larderia Inferiore e Superiore, presumibilmente nascono nello stesso periodo. La nascita e lo sviluppo dell'insediamento abitativo dove si trova ora Larderia Superiore si ha da ritenere che derivi dalle continue alluvioni che il paese ha subito; stare dalla parte alta del torrente significava evitare il rischio di vedersi distruggere anni e anni di sacrifici.
A Larderia Superiore si tiene la Festa di S.Sebastiano. La festa si ripete da un paio di anni dopo che fù abbandonata per lungo tempo senza un preciso motivo.
Un piccolo appunto su Larderia Superiore non per distinguere i due paesi che sono raccontati sempre a braccetto da LarderiaWeb.it ma, più semplicemente, per dare ancor più importanza al paesino di Larderia Superiore.
- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
Il Paese di Zafferia si trova nella zona sud della città di Messina. Fa parte della II circoscrizione denominata "della Calispera". Il villaggio si trova inserito in un contesto collinare distante dal mare circa 900 metri anch'esso proprio sotto il Monte Dinnammare, cima più alta del complesso montuoso dei peloritani.
Le origini di questo casale sono legate ad un'iniziativa dell'arcivescovo Nicolò, che governò la Chiesa messinese dal 1166 al 1183. Il prelato, infatti, concesse appezzamenti di terreno a chi era andato ad abitare in quella stessa contrada. Ma a condizione che ciascuno corrispondesse in cambio frumento, orzo, ceci e lino. Fu da quel primo nucleo di case che andò sviluppandosi il casale.
Il clero greco basiliano trovò spazio e consensi necessari per assurgere ad una posizione di egemonia. E ciò portò alla devozione per San Nicola di Bari nelle due chiese a lui dedicate, sia a Zafferia che a Pistunina. Ed anche alla Madonna, chiamata con 'titoli' orientali, come Santa Sofia e dell'Odigitria, o ancora dell'Itria.
Fu nel Seicento che ai greci subentrarono i Cappuccini. Questi rimasero a ridosso del casale fino alla soppressione delle corporazioni religiose, del 1866.
Alcune ricerche danno per certo che Tommaso Cannizzaro, spirito solitario, forse austero, senz'altro romantico, passò la maggior parte della sia vita in campagna, preferendola alla città, nei suoi possedimenti di Zafferia vivendo di rendita e dedicandosi agli studi letterari che lo appassionarono sin da giovane.
Da visitare la Parrocchia S.Nicola di Bari di Zafferia che si trova nella piazza principale del paese. L'antica parrocchia di San Nicola sorgeva sul margine destro del torrente di Zafferia. La sua costruzione risale ai primi del Settecento, ma oggi è degradata e semidistrutta. Aveva tre navate ripartite da pilastri ed era ricca di opere d'arte, tra le quali la tribuna affrescata da Letterio Paladino (1691-1743), alcuni altari policromi, e decorazioni di stucchi con cherubini e motivi vegetali. Fu distrutta dal terremoto del 1908.
La nuova parrocchia sorse sul lato opposto del torrente rispetto all'antica, lì dove si è sviluppato più intensamente l'abitato di Zafferia. La sua costruzione fu causate dall'esigenza di fornire ai fedeli un luogo di culto più grande rispetto all'area in cui si sviluppava l'antica parrocchia. Di quest'ultima, la chiesa di San Nicola di Bari conserva: un altare monumentale intarsiato, dedicato a Santa Sofia, una tavola di San Nicola di Bari, realizzata nel 1601 da Giuseppe La Falce, e una Santa Sofia, di Ignoto del XVI secolo.
Sulla sponda sinistra del torrente di Zafferia sorge Villa Pennisi, costruita tra i secoli XVII e XVIII.
Anche il paese di Zafferia ha la sua fortificazione. Precisamente si tratta di una Batteria antinave, riarmata in guerra con pezzi doppiocompito lontana dal mare circa 90/100 metri. Il compito principale di tale batteria fù il controllo e difesa del porto e della parte centromeridionale dello stretto. La batteria è stata attaccata dai velivoli angloamericani il 28 aprile 43. Dall’ 8 agosto 1943 aveva il compito specifico di difendere con le proprie artiglierie, (insieme a quelle di una batteria Flak da 88), il punto d’imbarco in zona Pistunina verso Gallico (RC) e viceversa, scelto dalle truppe Italotedesche in ritirata verso la Calabria. Purtroppo, come molte fortificazioni messinesi si trova in un pessimo stato, visibile solo la postazione più in basso, le altre tre sono state spianate o interrate.
Nella borgata di Zafferia si celebra un "Anno Santo" speciale ogni qual volta il Sabato Santo coincide con l'Annunciazione (25 marzo) si dice per concessione fatta dal Papa Sisto IV nel 1472 a Gianfilippo De Lignamine, un medico di Zafferia che lo aveva guarito da una grave malattia.
 Un altra notizia pervenutaci parla invece di Papa Urbano VI che concesse il privilegio mentre si trovava a passare per Messina nel 1385, ed ebbe bisogno di cure mediche, che un medico rimasto ignoto gli prestò. La Bolla originaria fu rubata al parroco don Mariano Guglielmo, che, per celebrare il Giubileo del 1758, dovette produrre, invece, testimoni che si presentarono perciò a un collegio di giureconsulti convocato dall’arcivescovo di Messina, Mons. Moncada. L’Archivio della parrocchia conserva documentazione dell’Anno Santo del 1690. Furono celebrati gli Anni Santi del 1769 e del 1780; poi ci fu una contesa con l'Arcivecovo di Messina, e si ricorse alla Santa Sede. Fu Pio VII che col Breve del 28 agosto 1816 che riconcesse il privilegio. L’ultimo è stato dall’ 8 aprile 1989 al 9 luglio 1990, e ce ne sarà un altro nel 2063. Giovanni Paolo II ha concesso il privilegio in perpetuo con rescritto della Penitenzieria Apostolica del 12 novembre 1988. L’Arcivescovo di Messina, l’8 aprile 1898 ha dato il nome a tale anno: Anno della Grande Indulgenza.
Un altra notizia pervenutaci parla invece di Papa Urbano VI che concesse il privilegio mentre si trovava a passare per Messina nel 1385, ed ebbe bisogno di cure mediche, che un medico rimasto ignoto gli prestò. La Bolla originaria fu rubata al parroco don Mariano Guglielmo, che, per celebrare il Giubileo del 1758, dovette produrre, invece, testimoni che si presentarono perciò a un collegio di giureconsulti convocato dall’arcivescovo di Messina, Mons. Moncada. L’Archivio della parrocchia conserva documentazione dell’Anno Santo del 1690. Furono celebrati gli Anni Santi del 1769 e del 1780; poi ci fu una contesa con l'Arcivecovo di Messina, e si ricorse alla Santa Sede. Fu Pio VII che col Breve del 28 agosto 1816 che riconcesse il privilegio. L’ultimo è stato dall’ 8 aprile 1989 al 9 luglio 1990, e ce ne sarà un altro nel 2063. Giovanni Paolo II ha concesso il privilegio in perpetuo con rescritto della Penitenzieria Apostolica del 12 novembre 1988. L’Arcivescovo di Messina, l’8 aprile 1898 ha dato il nome a tale anno: Anno della Grande Indulgenza.
- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
Tremestieri, ormai divenuto famoso per l'approdo omonimo, è un paesino dislocato sulla costa messinese estendendosi lungo la Via Consolare Valeria, un antica Strada Consolare Romana che univa Messina a Catania. Si sviluppò lungo la costa attorno al XIII secolo e tutto attorno all'antica Abbazia di Roccamadore (oggi Roccamotore) fondata nel 1197 da Bartolomeo De lucy, Conte di Paternò.
Dista 7 km dal centro di Messina e si estende per circa 2500 metri.
I terremoti del 1783 del 1908 hanno cancellato pezzi di storia della Prima Circoscrizione di Messina.
A Tremestieri, per esempio, fino al 1783 sorgeva il monastero cistercense di Santa Maria di Roccamodore (costruito nel 1197). Il monastero è legato all'ordine dei Cistercensi, nato in Francia nel 1098.
In Sicilia la sua diffusione fu favorita dagli Svevi. Il tempio aveva una propria autonomia economica e legava al culto, alcune attività lavorative (ad esempio agricoltura e pastorizia). Come tutte le abbazie cistercensi, anche questa (di cui oggi resta solo un vecchio cancello che costituiva l'ingresso laterale) era caratterizzata dalla severità del tracciato e dalla quasi totale assenza di sculture o dipinti d'autore. Secondo alcune fonti storiche, nell'area del monastero vi era anche un cenobio, intorno al quale si venerava un'icona bizantina della Madonna.
Uno dei più illustri abati del monastero fu Oliviero Pignatelli (1573), del quale ancora oggi viene conservato uno stemma marmoreo nella villa sorta sulle ceneri del Monastero. Della antica abbazia sopravvivono: il viale d'ingresso sulla via del Dromo, alcuni capitelli e lapidi inglobati nell'area del concessionario automobilistico, e uno spazio riservato ai monaci in meditazione, che oggi si trova all'interno di villa Mancini-Guttarolo (XIX secolo).
Dopo il terremoto, nell'area fu costruita la villetta dei Tasca, e in seguito l'abitazione, con elementi liberty, dello scultore Riccardo Mancini (oggi conosciuta come villa Guttarolo). Non esiste più la residenza dei d'Alcontres (rimane solo la cappella di famiglia). Mentre villa Colantuoni è stata recentemente ricostruita. Poco prima del bivio per Larderia c'è la chiesa parrocchiale di Santa Domenica.
 La chiesa parrocchiale di Santa Domenica è stata costruita nel 1928, sui ruderi di un tempio molto antico, costruito nel diciassettesimo secolo. La torre campanaria che la affianca, infatti, reca la data del 1605. Ha una forma quadrata, con cantonali di bugnato a rilievo, e cornici marcapiano a sezione semicircolare. La chiesa di Santa Domenica cadde sotto i colpi del sisma del 1908 (oggi si conservano soltanto due colonne al limite del sagrato che copre il vecchio cimitero, e che oggi è una piazzetta). Il campanile riuscì invece a resistere; a cadere furono soltanto i sette metri dell'ultimo piano. All'interno sono conservate numerose opere, tra cui: un trittico con Santa Domenica, Santa Lucia e Sant'Agata, attribuito ad Antonello De Saliba e datato 1501; un'acquasantiera rinascimentale con figure di Santi; la statua lignea di Santa Domenica, collocata sull'altare maggiore in marmo; due paliotti e uno stendardo ricamati in argento, con la figura della santa, conservati in sagrestia. Esiste ancora Villa Puleo (XIX secolo).
La chiesa parrocchiale di Santa Domenica è stata costruita nel 1928, sui ruderi di un tempio molto antico, costruito nel diciassettesimo secolo. La torre campanaria che la affianca, infatti, reca la data del 1605. Ha una forma quadrata, con cantonali di bugnato a rilievo, e cornici marcapiano a sezione semicircolare. La chiesa di Santa Domenica cadde sotto i colpi del sisma del 1908 (oggi si conservano soltanto due colonne al limite del sagrato che copre il vecchio cimitero, e che oggi è una piazzetta). Il campanile riuscì invece a resistere; a cadere furono soltanto i sette metri dell'ultimo piano. All'interno sono conservate numerose opere, tra cui: un trittico con Santa Domenica, Santa Lucia e Sant'Agata, attribuito ad Antonello De Saliba e datato 1501; un'acquasantiera rinascimentale con figure di Santi; la statua lignea di Santa Domenica, collocata sull'altare maggiore in marmo; due paliotti e uno stendardo ricamati in argento, con la figura della santa, conservati in sagrestia. Esiste ancora Villa Puleo (XIX secolo).
A Tremestieri era molto importante la celebrazione per la Madonna di Roccamodore, che cadeva il 2 febbraio (giorno della purificazione). Di tutti gli appuntamenti tradizionali, però, è rimasto soltanto quello di Santa Domenica, celebrato nella seconda domenica di luglio. Fuochi d'artificio e gare podistiche lunghe le vie del villaggio chiudono i festeggiamenti.
Tremestieri oggi è una punto nodale per quel che riguarda il trasporto marittimo sullo stretto ma purtroppo, oggi, i due moduli esistenti per l'attracco delle navi non è sufficente per smaltire l'afflusso continuo di TIR. Il paese subisce anche una crescita espanzionistica nel settore commerciale grazie ai vari centri commerciali che si sono insediati sul territorio, una crescita da subire dato che le infrastrutture viarie sono rimaste invariate. Tra i TIR, che tolti dal Boccetta, attraversano incessantemente la S.S. 114 e il Centro Commerciale di Tremestieri, una nota concessionaria d'auto, il Bingo ed i vari centri alimentari e di abbigliamento la zona ha raggiunto uno stato di caoticità forse unica in tutta Italia.
- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
 Mili Marina è un paese costiero della zona sud di Messina sviluppato in lunghezza segue parte della Via Consolare Valeria (oggi Via Nazionale), una antica Strada Conciliare Romana. Mili Marina vista la sua posizione costiera vanta diverse generazioni di famiglie di pescatori che si avventurano da diversi decenni nelle acque torbide dello stretto di Messina.
Mili Marina è un paese costiero della zona sud di Messina sviluppato in lunghezza segue parte della Via Consolare Valeria (oggi Via Nazionale), una antica Strada Conciliare Romana. Mili Marina vista la sua posizione costiera vanta diverse generazioni di famiglie di pescatori che si avventurano da diversi decenni nelle acque torbide dello stretto di Messina.
Non si hanno notizie storiche di questo villaggio, soggiogato dai paesi montani che vantavano Abbazie e Storie di Regnanti.
Degna di nota, a Mili Marina, l'ex chiesa di San Paolino Vescovo. Fu costruita nel diciassettesimo secolo e conserva una lapide che ricorda il suo fondatore Federico Rainerio. Nel 1956 ne fu costruita una nuova, che divenne parrocchia e fu intitolata a San Paolino Vescovo. Ogni anno si svolge la bella Processione del Santo di Mili lungo l'antica strada romana che attraversa il villaggio, oggi Via Nazionale. Santo Patrono del villaggio costiero, come detto è San Paolino. La storia del Santo Patrono di Mili Marina risale al 24 Agosto 1957 quando giunge a Moleti, via mare, la statua di San Paolino Vescovo di Nola. La statua, donata dalla famiglia Settineri, è stata realizzata dalla ditta Giuseppe Stuflesser di Ortisei, in provincia di Bolzano. L’ effige del Santo arriva a bordo di una imbarcazione di proprietà del Signor Rotondo accompagnata in processione da numerose barche. Ad attendere il Santo una grande folla di fedeli tra i quali anche bambini. Da qui in processione, tra bellissimi canti e struggenti preghiere, si giunge in parrocchia dove, ogni anno, il 24 agosto, si ricorda l'avvenimento.
- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese
Mili San Marco (o Mili Inferiore) è una frazione del comune di Messina, posizionata presso la Fiumara di Mili, a circa 2 km dallo svincolo autostradale di Tremestieri direzione Catania. L'appositivo San Marco fa riferimento all'intitolazione della parrocchia del paese.
 Da visitare a Mili San Marco la Parrocchia di San Marco Evangelista. Antichissima chiesa parrocchiale dedicata a San Marco. Crollò a causa di un'alluvione nel 1855 e fu ricostruita nel 1859 dall'architetto Mallandrino. Più precisamente la chiesa parrocchiale di San Marco fu costruita nel 1859, sulle rovine di un tempio precedente (caduto a causa di un'alluvione nel 1855). E' di stile neoclassico ed ha una pianta circolare.
Da visitare a Mili San Marco la Parrocchia di San Marco Evangelista. Antichissima chiesa parrocchiale dedicata a San Marco. Crollò a causa di un'alluvione nel 1855 e fu ricostruita nel 1859 dall'architetto Mallandrino. Più precisamente la chiesa parrocchiale di San Marco fu costruita nel 1859, sulle rovine di un tempio precedente (caduto a causa di un'alluvione nel 1855). E' di stile neoclassico ed ha una pianta circolare.
L'edificio, progettato da Giuseppe Mallandrino e mutuato dal Pantheon di Roma, è caratterizzato da un pronao, piantato su due solide colonne, e da una cupola. All'interno è conservato un altare marmoreo, ricco di tarsie marmoree e con la statua dello stesso San Marco, patrono del villaggio (secolo XVII). L'edificio è stato parzialmente ristrutturato nel 1960.
I casali storici della vallata di Mili sono Mili San Pietro e Mili San Marco. A partire dal tempo dei Normanni, entrambi hanno avuto come punto di riferimento il monastero di Santa Maria, la cui costruzione fu voluta dal conte Ruggero. Lo stesso monastero esercitò la propria giurisdizione sui casali fino al 1400, anno in cui il cenobio fu concesso ad un vescono da parte di Ferdinando il Cattolico. L'imperatore Carlo V, col parere favorevole del Pontefice, assegnò tutte le rendite all'ospedale della Pietà, che nel 1542 riunì una dozzina di nosocomi cittadini. Nel 1685 i due casali, come anche tutti gli altri casali montani, furono venduti da Bonavides. Alla città furono restituiti nel 1727, dopo quarant'anni. Importanza fondamentale in tutta l'area fu esercitata dagli inglesi. Nel 1810, infatti, accorsero in aiuto dei borbonici, che temevano l'invasione della Sicilia da parte dei Francesi di Gioacchino Murat. In quella occasione propiziarono la costruzione della strada che tuttora collega entrambi i casali alla città.
Appuntamento molto sentito a Mili San Marco era quello del 25 aprile, giorno del Protettore, che festeggiava proprio San Marco. Le donne dei villaggi della vallata di Mili cucinavano ricche portate di carne, paste e dolci con uova o carciofi. Sempre a Mili San Marco, la prima domenica di settembre, si festeggia invece San Sostine (un soldato romano perseguitato per essersi convertito al cristianesimo). Il santo viene invocato alla fine dell'estate perché porti la prima pioggia dell'autunno. La sua statua, inoltre, viene portata nell'omonima cappella allestita in collina, in una processione che passa anche per la chiesa basiliana di Santa Maria.
- Dettagli
- Categoria: Vicini di Paese

Sita nella zona Sud del territorio cittadino, a 199 m. d'altitudine, all'interno della vallata del torrente Mili, coltivata prevalentemente ad agrumeti, oliveti e vigneti e rigogliosa di vegetazione mediterranea.
 I tre casali di Mili Marina, Mili S. Marco e Mili S. Pietro nacquero a ridosso della fiumara di Mili. Ma i casali storici della vallata di Mili, in effetti, sono Mili San Pietro e Mili San Marco. A partire dal tempo dei Normanni, entrambi hanno avuto come punto di riferimento il monastero di Santa Maria, la cui costruzione fu voluta dal conte Ruggero. Lo stesso monastero esercitò la propria giurisdizione sui casali fino al 1400, anno in cui il cenobio fu concesso ad un vescono da parte di Ferdinando il Cattolico. L'imperatore Carlo V, col parere favorevole del Pontefice, assegnò tutte le rendite all'ospedale della Pietà, che nel 1542 riunì una dozzina di nosocomi cittadini. Nel 1685 i due casali, come anche tutti gli altri casali montani, furono venduti da Bonavides. Alla città furono restituiti nel 1727, dopo quarant'anni. Importanza fondamentale in tutta l'area fu esercitata dagli inglesi. Nel 1810, infatti, accorsero in aiuto dei borbonici, che temevano l'invasione della Sicilia da parte dei Francesi di Gioacchino Murat. In quella occasione propiziarono la costruzione della strada che tuttora collega entrambi i casali alla città.
I tre casali di Mili Marina, Mili S. Marco e Mili S. Pietro nacquero a ridosso della fiumara di Mili. Ma i casali storici della vallata di Mili, in effetti, sono Mili San Pietro e Mili San Marco. A partire dal tempo dei Normanni, entrambi hanno avuto come punto di riferimento il monastero di Santa Maria, la cui costruzione fu voluta dal conte Ruggero. Lo stesso monastero esercitò la propria giurisdizione sui casali fino al 1400, anno in cui il cenobio fu concesso ad un vescono da parte di Ferdinando il Cattolico. L'imperatore Carlo V, col parere favorevole del Pontefice, assegnò tutte le rendite all'ospedale della Pietà, che nel 1542 riunì una dozzina di nosocomi cittadini. Nel 1685 i due casali, come anche tutti gli altri casali montani, furono venduti da Bonavides. Alla città furono restituiti nel 1727, dopo quarant'anni. Importanza fondamentale in tutta l'area fu esercitata dagli inglesi. Nel 1810, infatti, accorsero in aiuto dei borbonici, che temevano l'invasione della Sicilia da parte dei Francesi di Gioacchino Murat. In quella occasione propiziarono la costruzione della strada che tuttora collega entrambi i casali alla città.
 Mili S. Pietro è rinomata soprattutto perché vi sorge l'importante Chiesa normanna di Santa Maria di Mili, risalente al 1092 e rilevante meta turistica.
Mili S. Pietro è rinomata soprattutto perché vi sorge l'importante Chiesa normanna di Santa Maria di Mili, risalente al 1092 e rilevante meta turistica.
Proprio dalla chiesa di Santa Maria e dal monastero normanno che le era affiancato, la Prima Municipalità ha preso il nome "Normanno". Del monastero restano soltanto dei ruderi, ma la chiesa è ancora in piedi. Si tratta delle più antiche costruzioni di tutta la provincia di Messina e sono datate 1092. La loro fondazione fu propiziata dal conte normanno Ruggero D'Altavilla. La chiesa è costituita da una navata unica, con tre absidi che si aprono sul transetto, sormontate da tre cupolette emisferiche, tipiche dell'architettura arabo-normanna. La costruzione fu eseguita con laterizi e materiale pietroso policromo. Fu ristrutturata nel Cinquecento, e in quell'occasione la navata unica fu allungata. Intorno alla chiesa restano i ruderi del monastero. Fin dall'inizio il conte Ruggero aveva stabilito che nella chiesa venissero custodite le spoglie di suo figlio Giordano (prima condannato a morte per essersi ribellato al padre, poi graziato, e infine deceduto per cause naturali proprio nel 1092). A seguito delle leggi eversive del 1862, chiesa e monastero furono confiscati; la prima andò al demanio, il secondo ad alcuni privati che lo avevano acquistato. Entrambi versano in condizioni d'abbandono.
Da segnalare l'Eremo di S. Sostine ....
Sorge nel Villaggio di Mili San Pietro, su un poggio ricco di vegetazione dominando tutto il centro abitato. Conserva un pregevole altare intarsiato del '700 con simbologie basiliane, e questo fa supporre che gli eremiti che lo avevano in cura s'ispirarono alla Regola e alla spiritualità di San Basilio. La statua marmorea di San Sostene è datata 1634.









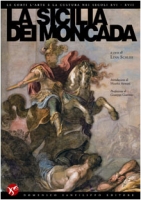

 Home Page
Home Page